 |
| Anello-sigillo di Trezzo d'Adda, VIII secolo, Milano |
I Longobardi giunsero in Italia nel 568- 569 d.C . Non è chiara la motivazione della loro venuta , se per libera iniziativa o in nome di qualche accordo con i Bizantini ( che l'avevano strappata ai Goti dopo la guerra Greco - Gotica (535 -553 d.C). Certo, l'Italia era lontana e di difficile amministrazione...Per i Bizantini non sarebbe stato strano intrattenere buoni rapporti con una popolazione mercenaria al fine di controllare il paese indirettamente.
Ricordiamo brevemente che, per quanto concerne la loro presunta discesa dalla Scandinavia, teoria che si legge ancora su molti libri e su molte fonti telematiche, una buona parte degli storici, tra cui Stefano Gasparri , docente di Storia medievale presso l’ Università Ca’ Foscari di Venezia, basandosi su recenti studi linguistici effettuati sulle antiche fonti ( Origo gentis Langobardorum del VII secolo e l’Historia Langobardorum di Paolo Diacono) e sulle nuove metodologie in campo archeologico, ritiene superata questa teoria in base alla quale questo popolo, poco prima dell’inizio dell’era cristiana, sarebbe giunto dalla Scandinavia dopo una lunga peregrinazione, orbitando tra l’Elba e il Danubio.
Quel che è certo dalle fonti archeologiche, come ci ricorda il professor Alessandro Barbero, docente di Storia medievale presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro, è che questi barbari, il cui primo nome fu Winnili ( come ricorda Paolo Diacono ) scesero dal Danubio, giungendo con uomini, donne, bambini, anziani e masserizie , attraversando il Friuli. Erano esperti di combattimento su terra e non avevano dimestichezza con le tecniche marittime . Per questo , inizialmente, non presero Genova, Napoli e Ravenna ove stazionavano ancora le flotte romane . Non riuscirono a conquistare neanche Roma perchè, seppur in declino, da grande città , era ancor ben difesa da una grossa guarnigione. Riuscirono ad occupare il resto d'Italia fino a Sud, fino a Bari e alla Calabria. Solo in ultimo riusciranno a far loro Genova e poi anche Ravenna alla metà dell'VIII secolo.
 |
Lastrina dello Scudo di Stabio, VII secolo, bronzo dorato
Berna, Historisches museum |
Tornando alla loro discesa in Italia, l' archeologia ci attesta l'assenza di segni di distruzione al loro passaggio.I Longobardi diventarono i nuovi padroni e si diffusero lentamente in gran parte d'Italia, confiscando le terre ai ricchi per darle ai guerrieri. Ogni guerriero divenne un piccolo signorotto con contadini italiani al suo servizio. Non ci fu dunque resistenza, nè lotta nel nostro paese, all'epoca scarsamente abitato da circa un milione di persone sparse su tutta la penisola. Persone che chiamavano loro stesse "romane", di lingua latina e di fede cristiana cattolica. Al contrario, i Longobardi erano ariani e di lingua germanica e definivano il loro popolo "exercitus" . A differenza degli Unni di Attila il cui solo scopo era la razzia, ambivano all'agiato modus vivendi romano, in declino ma non ancora completamente distrutto. A Milano, ad esempio, c'era ancora un Ippodromo funzionante.
 |
| Lamina di Agilulfo ,600 circa, Museo del Bargello di Firenze. |
In generale. per quanto orgogliosi della loro identità ,i popoli germanici insediati nei vari paesi dell'ex Impero romano d'Occidente, erano consci del gioco forza politico con la parte Orientale dell'Impero. Come fare per ottenere da costoro il riconoscimento della propria autorità, il rispetto e la considerazione? La risposta era solo una: con l'emulazione dello stile di vita, dell'abbigliamento e delle insegne imperiali, con la tipica gestualità del potere utilizzata e perfezionata nei secoli dalle alte cariche romane. La Lamina di Agilulfo, datata al 600 circa, è una testimonianza preziosa che attesta proprio questa dinamica.
Conservata al Museo del Bargello di Firenze, apparteneva probabilmente a un elmo a lamelle del quale componeva la parte frontale oppure era il rivestimento di una preziosa cassetta. Raffigura il sovrano Agilulfo attorniato da armati e Vittorie, omaggiato da sudditi in devota sottomissione. Agilulfo siede in trono, vestito e armato alla germanica : il modo di indossare il mantello, i pantaloni e la presenza della spatha longobarda ben stretta nella sinistra che appare poggiata sul ginocchio sono chiara manifestazione della gestualità del potere. Ma non solo. Agilulfo con la mano destra alzata emula il gesto della parola , tipico dell'iconografia imperiale romana. L'autore della lamina si ispira a modelli tardoantichi: per Agilulfo ai dittici consolari, per le Vittorie alle monete bizantine e longobarde , per gli omaggi alle scene di sottomissione all'Imperatore raffigurati su dittici o monumenti come la Colonna di Costantino ( 326 -330 d.C ) .
 |
| Contratto di matrimonio, 1028, Bari, Cattedrale, Archivi.
|
Fare i conti con la cultura romana, non implicava solo l'emularne il modus vivendi, ma an
che studiarne le leggi. La giurisdizione romana era altro mondo rispetto a quella longobarda che, il sovrano Rotari racchiuse per la prima volta per iscritto nel famoso Editto nel 643.
Due mondi diversi , insomma, due mondi che dovevano trovare una conciliazione, anche giuridica. Molti anni dopo, al sovrano longobardo Liutprando toccò arbitrare una incresciosa vicenda giuridica.
Siamo nel 731 d.C: i sovrani barbarici si confrontano con la cultura romana, studiandone la difficile legislazione affiancata alle più pratiche leggi germaniche. E' inutile dirlo: la coesistenza di diversi diritti sul territorio di un medesimo regno comportava dei seri problemi...Come quello che il nostro sovrano fu chiamato a risolvere.
Cosa succede se un romano sposa una longobarda e si assume il suo mundio ( cioè la giurisdizione su di lei )? E cosa accade se alla sua morte quella donna vorrà risposarsi senza il permesso degli eredi del primo marito ? Costoro potranno aver diritto ad un risarcimento? In generale per i longobardi , una donna vedova non ha il diritto di risposarsi senza il consenso di chi detiene il suo mundio, cioè figli o eredi del defunto marito. Nel particolare essendosi sposata un romano ella stessa è diventata tale così come i figli nati da quel matrimonio . Perciò chi la sposa in seconde nozze non dovrà pagare nessun risarcimento agli eredi e alla famiglia del marito defunto.
A.Barbero, C.Frugoni, Medioevo. Storia di voci, racconto di immagini, Laterza, 2015.
S. Gasparri, La migrazione longobarda in Italia tra mito e realtà, in Le migrazioni nell’Alto medioevo, Settimane di studio della Fondazione Centro Italiano di Studi sull’Alto medioevo LXVI, Spoleto 5-11 aprile 2018, pp. 376 - 395, Fondazione Centro Italiano di Studi sull’Alto medioevo, Spoleto ,2019.




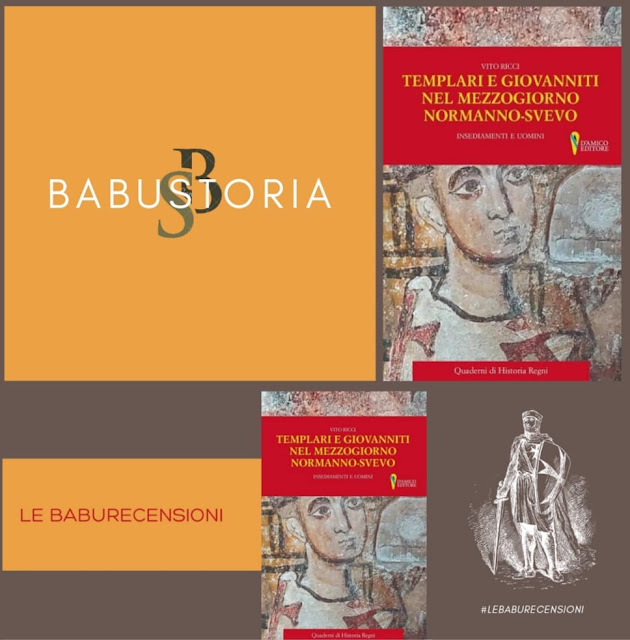

Commenti
Posta un commento