L'Arte araldica Medievale in pillole
Gli stemmi non sono appannaggio esclusivo dei nobili nè tantomeno possono essere considerati materia di studio esoterico.
Nato sui campi di battaglia e nei tornei, lo stemma era il simbolo identificativo attorno a cui si riuniva una famiglia e tutti, in ogni dove, potevano adottarne uno.
Quindi è assolutamente sbagliata l'idea che lo stemma fosse un diritto nobiliare, riservato all'aristocrazia. Bisogna però precisare che, anche se l'utilizzo dello stemma era aperto a tutti, non tutti ce l'avevano ( come i biglietti da visita odierni ).
I nobili furono i primi ad utilizzarli ma , grazie ai sigilli, l'uso degli stemmi si estese via via a tutte le altre classi sociali ( ai non combattenti, alle persone giuridiche , alle donne, alle città, ai prelati, ai patrizi , ai borghesi e, in alcune regioni come Normandia, Fiandre, Svizzera e Inghilterra meridionale, anche ai contadini). La Chiesa iniziò ad adottarli dal pontificato di Nicola III ( fine XIII secolo ).
Lo stemma si componeva di vari elementi ed era colorato con precise tonalità, identificative per quel gruppo familiare specifico . Lo studio degli stemmi rientra nell'araldica. Questa parola deriva dal termine di origine germanica "araldo" con cui inizialmente si designava un messaggero, ovvero un piccolo ufficiale domestico al servizio di un principe o di un barone. Oggi giorno, grande influenza dell'araldica è presente in campo sportivo ( divise, gagliardetti, stendarti, sciarpe molto spesso custodi di emblemi risalenti a diversi secoli fa ).
 |
| Stemmi inglesi, dal Grande armoriale equestre del Toson d'oro e dell'Europa, Lille, 1435 circa, Parigi, Bibliothèque de l'Arsenal, Ms. 4790, f. 79v. |
Nel linguaggio comune si tende spesso a considerare sinonimi le parole "stemma" e "blasone".
Il blasone designa l'insieme di figure, colori e regole araldiche. Con il verbo "blasonare" si intendeva sin dal XIV secolo l'arte di saper descrivere gli stemmi nella lingua professionale degli araldi d'arme. Le dirette eredi del blasone medievale sono le bandiere.
Per emblema invece si intende il segno che esprime l'identità di quell'individuo o gruppo di persone ( stemma, uniforme, attributi iconografici). Il simbolo è invece l'idea, la nozione astratta , il concetto che si vuole far trasparire attraverso certe figure, colori o oggetti ( amore, giustizia, tempo etc...).
La comparsa e la diffusione degli stemmi si dispiega in tre fasi ( gestazione, comparsa, diffusione) tra la metà del X secolo e gli anni Trenta del XIII secolo e non fu un evento isolato. Dopo il crollo dell'Impero carolingio con l'emergere di un nuovo ordine sociale, "signorile" e non più "feudale" , lo stemma fu il prodotto della rinnovata necessità di identificarsi, riconoscersi e proclamarsi ( che ben si esprime anche attraverso i patronimici o il tipo e il colore degli abiti ). Quindi, in generale, gli stemmi non ebbero una culla definita ma comparvero contemporaneamente in diverse zone.
La comparsa e la diffusione degli stemmi si dispiega in tre fasi ( gestazione, comparsa, diffusione) tra la metà del X secolo e gli anni Trenta del XIII secolo e non fu un evento isolato. Dopo il crollo dell'Impero carolingio con l'emergere di un nuovo ordine sociale, "signorile" e non più "feudale" , lo stemma fu il prodotto della rinnovata necessità di identificarsi, riconoscersi e proclamarsi ( che ben si esprime anche attraverso i patronimici o il tipo e il colore degli abiti ). Quindi, in generale, gli stemmi non ebbero una culla definita ma comparvero contemporaneamente in diverse zone.
Gli stemmi sono costituiti da due elementi fondamentali : le figure e i colori .
Questi due elementi non possono essere combinati arbitrariamente ma rispondono a regole ben precise . Infatti, all'interno di uno scudo , figure e colori dovevano essere combinati scrupolosamente. Ricordiamo che nel Medioevo gli stemmi potevano essere privi di figure ma non di colore.
Questi due elementi non possono essere combinati arbitrariamente ma rispondono a regole ben precise . Infatti, all'interno di uno scudo , figure e colori dovevano essere combinati scrupolosamente. Ricordiamo che nel Medioevo gli stemmi potevano essere privi di figure ma non di colore.
Lo scudo era composto da assi di legno , internamente imbottito ed esternamente rivestito di tela, cuoio, pergamena o pelliccia. Era provvisto esternamente di una "borchia" o "umbone" , protuberanza metallica più o meno prominente ( in alcuni casi finemente cesellata o intarsiata ) . Le forme degli scudi erano varie: triangolo ( la più frequente e di eredità feudale), triangolo isoscele ( dalla prima metà del XIII secolo) , quadrato, rettangolo, rotondo, ovale, a cuore, losanga , a forma di foglia, fiore o conchiglia.
Le figure utilizzate , per lo più stilizzate, potevano essere animali, elementi geometrici, luna crescente, anellini, stelle, conchiglie , armi, attrezzi, edifici come torri o castelli o elementi vegetali come gigli, rose o trifogli.
L'araldica medievale utilizza soltanto sei colori ( rosso, bianco, giallo, blu- azzurro, nero e verde) a tinta unita , concettuali, quasi astratti, combinati secondo la regola dell'associazione : i colori , divisi in due gruppi ( nel primo vi sono il bianco e il giallo, nel secondo il il rosso, il nero, il blu e il verde) non potevano essere giustapposti o sovrapposti se dello stesso gruppo. Questa regola verrà meno alla fine del Medioevo, con la fusione di più stemmi in uno.
Bibliografia:
M. Pastoureau, L'arte araldica nel Medioevo, Einaudi, 2019.




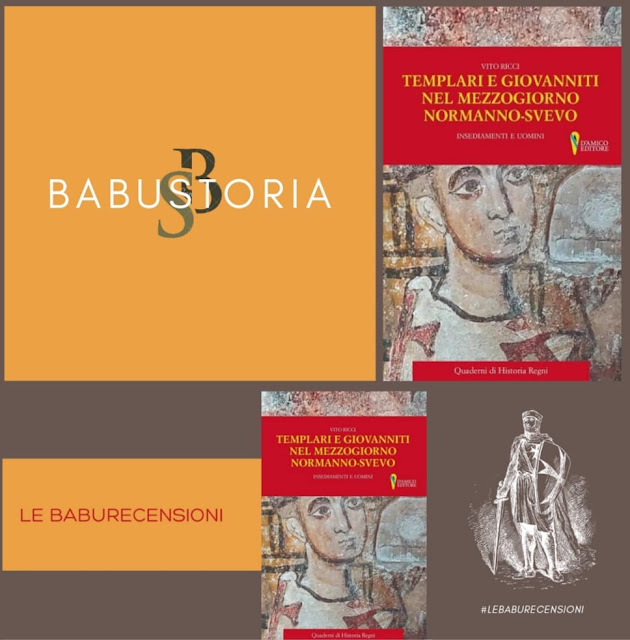

Commenti
Posta un commento