Le Favole nel Medioevo : breve quadro storico
 |
| Miniatura dal Roman de Renart, fine del XIII secolo |
Le favole sono racconti fantastico-didascalici con animali umanizzati protagonisti di piccoli racconti edificanti. Nel Medioevo, a partire dal Duecento , ne fecero largo uso i frati degli Ordini mendicanti come il domenicano Vincenzo di Beauvais (1190 ca.-1264) che ne incluse ben ventinove in due sue opere (lo Speculum historiale e lo Speculum doctrinale ). Le favole ravvivavano i sermoni dei dotti fornendo ai fruitori spunti chiari di comprensione e riflessione. Erano note le favole di Fedro ( che circolarono abbondantemente fino fino al sec. X ) , di Aviano ( IV sec. ) o la silloge Romulus. A questo punto é bene fare una precisazione. In epoca medievale le favole definite esopiche ( perché provviste di morale ) con animali come protagonisti che si comportavano e parlavano come esseri umani, erano molto popolari. Benché fosse conosciuto Esopo, il creatore del genere, era più noto Fedro che trovò in un certo Romolo il suo corrispettivo medievale! Romulus avrebbe tradotto dal greco le favole di Esopo per farle conoscere al figlio Tiberino. Il Romulus si presentava in tre versioni : il Romulus Ordinarius ( la versione più ampia e più vecchia con 83 favole, risalente probabilmente al IX secolo), il Romulus di Vienna e Il Romulus di Nilant ( con 45 favole pubblicate nel 1709 da Johan Frederik Nilant ).Oltre il Romulus, ricordiamo anche la collezione del monaco Ademaro di Chabannes del 1025, l'Ysopet di Maria di Francia ( seconda metà del sec. XII ) e il tardotrecentesco Esopo toscano .
 |
| Codice medievale di Ysopet |
L’arte non poteva esimersi dall’onorare le favole : pensiamo ad esempio al complesso del tardo Duecento affrescato nella sala dei Notari nel palazzo dei Priori a Perugia con ben undici favole esopiane ( provviste di morale ) corredate da scritte : vi sono il lupo e l'agnello, il cane che porta la carne, il lupo e la gru, la volpe e il corvo, la volpe e l'uva, il leone e la volpe e così via. Queste scene, unite a tematiche bibliche ( Storie della vita di Mosè, di Gedeone e di Adamo ed Eva fino alla morte di Caino ) hanno funzione allegorica ed invitano alla prudenza i governanti , sempre attenti a non sottovalutare i nemici. A Perugia, nel bacino inferiore della fontana Maggiore, situata nella piazza adiacente al Palazzo dei Priori, Giovanni e Nicola Pisano , tra 1275 e 1278, rappresentarono tra i vari soggetti anche le favole del lupo e dell'agnello e del lupo e della volpe e la gru.
Soggetti favolistici , utilizzati con ironico contrappunto, sono ampiamente utilizzati per commentare le imprese umane nell’Arazzo di Bayeux , celebre testimonianza delle vicende che portarono alla vittoria di Guglielmo il Conquistatore ad Hastings nel 1066. La favola del leone magnanimo , dolce con il suo cucciolo ma feroce con chi gli si oppone, era dipinta sul portale del palazzo Senatorio a Roma. La raffigurazione, risalente al 1300 circa, é oggi perduta. Un leone magnanimo é rappresentato nei bassorilievi della facciata della chiesa di S. Pietro a Spoleto insieme ad altre cinque che hanno per protagonisti animali e che nel complesso simboleggiano gli agguati del Maligno : leoni con la zampa imprigionata in un albero o con una preda in ostaggio o l’astuta volpe che si finge morta , il leone che assale un drago ( o la pantera in lotta con un drago ) o il lupo con il cappuccio monacale che medita di azzannare un ariete, chiara caricatura del clero e dei suoi vizi ( tale storia fu narrata da Maria di Francia e perfino citata in una bolla di Urbano II nel 1096 ). Tra XII e XIII sec. i soggetti delle favole tornano nella cattedrale di Friburgo in Brisgovia, nella collegiata di St. Ursanne, in Svizzera, in un codice conservato a Heidelberg e, in Italia, in un capitello della cattedrale di Parma, in un rilievo nel portale occidentale della cattedrale di Ferrara. Infine, nella porta della Pescheria della cattedrale di Modena , si trovano sull’architrave i rilievi con i funerali della volpe e con la storia del lupo e della gru, mentre lungo gli stipiti si snoda una serie di storie di animali .
Concludo con la più celebre favola medievale : il Roman de Renart . Si tratta di una celebre raccolta di testi del XII e XIII sec., in cui gli animali si comportano come uomini. Protagonisti delle vicende sono la goupil ( la volpe ) Renart e il suo antagonista , il lupo Ysengrim , entrambi mossi dall’imperioso bisogno di colmare un ventre vuoto. É la fame a spingere gli animali a fare di tutto, specialmente l’illecito : Renart é costretto anche a rubar cibo ( specialmente prosciutti e formaggi ) per non morire di fame o a tessere tranelli non solo a danno del lupo, suo antagonista, ma anche dei mercanti lungo i tracciati al fine di rubarne parte delle mercanzie . La furba volpe arriverà a fingersi morta pur di essere caricata sui carri dei viandanti e sottrar loro agevolmente le cibarie…per darsi indisturbato alla macchia e tornare velocemente alla sua dimora Malpertugio , dalla moglie Hersent e dai figli.
 |
| Il Roman de Renart in una miniatura medievale |
Bibliografia:
A. Goldschmidt, An Early Manuscript of the Aesop's Fables of Avianus and Related Manuscripts (Studies in Manuscript Illumination, 1), Princeton 1947;
B.E. Perry, Aesopica. A Series of Texts Relating to Aesop or Ascribed to him or Closely Connected with the Literary Tradition that Bears his Name, Urbana (IL) 1952;
C. Acidini Luchinat, C. Frugoni, M. Chiellini Nari, La porta della Pescheria nel Duomo di Modena, Modena 1991.C. Frugoni
C. Frugoni, Una lontana città. Sentimenti e immagini nel Medioevo, Torino 1983;
C.Frugoni, Paure Medievali, Epidemie, Prodigi, Fine del Tempo, pp. 124 - 125, Il Mulino, 2020;
G. Chenesseau, L'abbaye de Fleury à Saint-Benoît-sur-Loire, Paris 1931;
G. Moretti, ''L'uomo e il leone'': exempla nella favola e la favola come exemplum in "Atti del V Colloquio della International Beast Epic Fable and Fabliau Society, Torino-Saint-Vincent 1983", a cura di A. Vitale Brovarone, G. Mombello, Alessandria 1987, pp. 201-211;
G. Thiele , a cura di, Der illustrierte lateinische Aesop in der Handschrift des Ademar, Leiden 1905;
G. Thiele, a cura di, Der lateinische Aesop des Romulus und die Prosa-Fassungen des Phaedrus, Heidelberg 1910;
E.P. Evans, Animal Symbolism in Ecclesiastical Architecture, London 1896 (rist. anast. Detroit 1969);
F. Bertini, Gli animali nella favolistica medievale dal ''Romulus'' al secolo XII, in “L'uomo di fronte al mondo animale nell'Alto Medioevo”, "XXXI Settimana di studio del CISAM, Spoleto 1983", II, pp. 1031-1051, Spoleto 1985;
J.L. Esch, La chiesa di S. Pietro di Spoleto. La facciata e le sculture, Firenze 1981;
K. Weitzmann, Ancient Book Illumination, Cambridge (MA) 1959, p. 47ss.;
L. Hervieux, Les fabulistes latins, dépuis le siècle d'Auguste jusqu'à la fin du Moyen Age, 5 voll., Paris 1884-1899 (New York 19652);
L.M.C. Randall, Exempla as a Source of Gothic Marginal Illumination, ArtB 39, 1957, pp. 97-107;
L.M.C. Randall, Images in the Margins of Gothic Manuscripts (California Studies in the History of Art, 4), Berkeley-Los Angeles 1966;
L. Hermann, Les fables antiques de la broderie de Bayeux (Collection Latomus, 69), Bruxelles 1964;
V. Branca, a cura di, Esopo toscano dei frati e dei mercanti trecenteschi, a cura di V. Branca, Venezia 1989 (con bibl.);


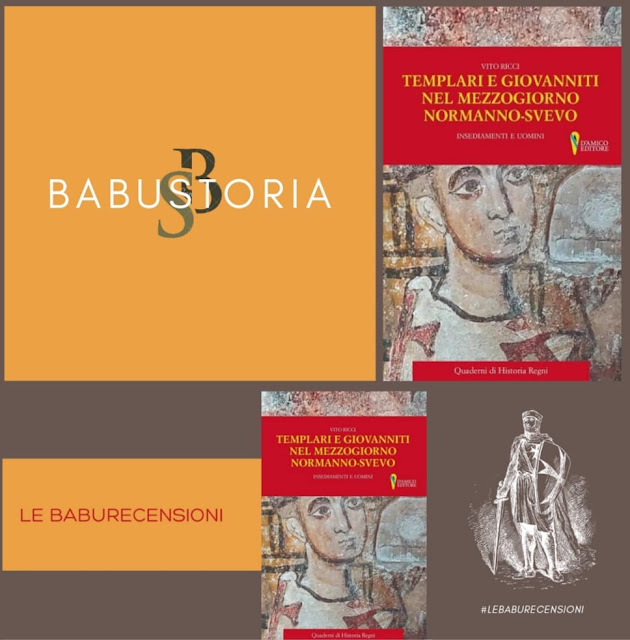

Commenti
Posta un commento