Sant'Eligio di Noyon
"C’era anche una monaca, una Priora,
dal sorriso semplice e modesto:
il suo più gran giuramento non era che per sant’Eligio,
e si chiamava madre Eglantina".
G. Chaucer, I racconti di Canterbury, a cura di E. Barisone, Milano 1999
 |
| Petrus Christus, Sant'Eligio nella bottega di un orefice, 1449, New York, Metropolitan Museum of Art |
Eloi, Eligius, Alar, Loy, Aloy, Elouis, Alò, Lò.
Ecco i vari nomi con cui è indicato sant' Eligio.
Importante per lo studio del santo è la Vita Eligii Episcopi Noviomensis attributa al contemporaneo e amico Audoeno . L’opera fu rimaneggiata nel primo quarto dell' VIII secolo da un monaco dell'abazia di Noyon. Eligio nacque intorno al 588 a Chaptelat .
Sin da piccolo dimostrò una notevole propensione per i lavori di precisione : per questo, fu mandato a bottega dal maestro Abbone a Lemovices , per continuare in seguito il suo apprendistato a Limoges. Dopo la formazione, si recò a Parigi per lavorare come orafo e monetiere.
La sua bravura ed onestà colpirono i sovrani Clotario II e Dagoberto I per i quali lavorò come orafo di corte . I gioielli più richiesti provenivano dalla Gallia, dall'Elvezia e dai Pirenei ( smeraldi, zaffiri, topazi, quarzi , diamanti, madreperla). Erano ambiti anche preziosi in osso e paste vitree. Questi ultimi erano materiali più economici utilizzati in una Gallia le cui entrate, nel VII secolo, erano superiori alle uscite.
La sua bravura ed onestà colpirono i sovrani Clotario II e Dagoberto I per i quali lavorò come orafo di corte . I gioielli più richiesti provenivano dalla Gallia, dall'Elvezia e dai Pirenei ( smeraldi, zaffiri, topazi, quarzi , diamanti, madreperla). Erano ambiti anche preziosi in osso e paste vitree. Questi ultimi erano materiali più economici utilizzati in una Gallia le cui entrate, nel VII secolo, erano superiori alle uscite.
Eligio fu l'autore di diverse opere : croci, placche, il calice di Santa Genoveffa e le tombe di San Martino di Tours e San Dionigi di Parigi. Alla morte di Dagoberto, per ordine del quale il santo fu incaricato di sovrintendere i lavori a St. Denis, Eligio fu ordinato sacerdote , divenendo nel 641 vescovo di Noyon .
Onesto, integerrimo e di grande tempra morale, fu abile predicatore, fondò monasteri a Noyon e Solignac, lavorò attivamente nelle Fiandre per combattere l'eresia pagana.
Onesto, integerrimo e di grande tempra morale, fu abile predicatore, fondò monasteri a Noyon e Solignac, lavorò attivamente nelle Fiandre per combattere l'eresia pagana.
Morì nel 659 o 660.
Per quanto concerne l'attività di orafo e monetiere del santo , risulta difficile tracciarne l'iter dato che la sua fama leggendaria di vescovo benefattore ha superato quella dell'artigiano, compiendo una sorta di sovrapposizione. Il culto del beato vescovo appare già ben diffuso nel Nord della Francia e del Belgio sin dal VII secolo per poi espandersi a sud. Non c'era chiesa o complesso religioso in Francia che non vantasse di possedere un prezioso realizzato da Eligio. Su di lui fioccarono miracolose leggende e Eligio divenne il protettore degli orafi, fabbri, stagnari, chincaglieri e soprattutto maniscalchi.
Il suo culto dal Limousin si diffuse nella Francia del Nord, nelle Fiandre, in Germania, in Italia ( a Bologna, Napoli e Roma ). Particolarmente venerato dalle corporazioni degli orafi e dei maniscalchi ( specie dal XIV secolo ), raggiunse la massima popolarità nel Tardo Medioevo.
A partire dal XIV secolo, si diffonde il miracolo più famoso di Eligio : il santo avrebbe tagliato e poi rimesso a posto una zampa di un cavallo per poterla ferrare più comodamente. Dato che la pratica di ferrare i cavalli si è affermata a partire dal XII secolo , la leggenda è nata molto tempo dopo la morte di Eligio, avvenuta nel VII secolo.
L’iconografia del santo orafo è proposta da Petrus Christus nel dipinto realizzato nel 1449 per la gilda degli Orefici di Anversa ( in foto sopra ) . L'opera conservata al Metropolitan Museum of Art di New York ritrae il santo in una bottega di orafo intento nel scegliere un anello per una coppia di fidanzati.
Oltre alla protezione di orefici, coltellinai, maniscalchi, fabbri, sellai, carrettieri, mercanti di cavalli, il Santo era invocato contro gli incendi. In età moderna il culto è ravvivato dalle Confraternite di sant’Eligio ( composte da artigiani, contadini e da persone impegnate in attività legate al mondo dei cavalli).
La sua festa ricorre il 1° dicembre mentre la sua traslazione si ricorda il 25 giugno.
L' iconografia di Eligio è sempre legata al mondo dell'oreficeria, della cura dei cavalli o alla sua attività pastorale. Tra le testimonianze più antiche annoveriamo le insegne di pellegrinaggio in piombo ritrovate nella Senna in prossimità dell’antico Priorato di Sant’Eligio, a Parigi .
Trattasi di una raffigurazione sintetica ma efficace, in cui spiccano la figura del maniscalco, con incudine, tenaglie, ferro e zampe di cavallo o dell’orafo, con il calice e l’anello oppure del vescovo, con mitra, pastorale, libro, arricchito in alcuni casi dalla presenza delle tenaglie, del ferro di cavallo e del cavallo stesso. Due insegne in piombo e stagno, databili al XIV secolo , conservate una nel Museum of London , l’altra a Cothen ( sotto in foto ) nella Collezione H.J.E. van Beuningen, ripropongono il medesimo tipo iconografico.
 |
| Cothen, Collezione H.J.E. van Beuningen. Insegna di Sant’Eligio maniscalco (da M. D’Onofrio [a cura di], Romei e Giubilei … cit., 359). |
La presenza di sant’Eligio è attestata in molti centri pugliesi. A una fase angioina di affermazione e diffusione del culto ( fine del XIII secolo e inizi del XIV ) , segue l’interesse per il Santo in età aragonese seguita da una ravvivata vivacità del culto in età moderna ( tra XVI e XVIII secolo ) legata in particolare alle Confraternite.
Sant'Eligio è un santo d'Occidente venerato in concomitanza di culti di matrice orientale in molti centri pugliesi . Ad esempio, a Monopoli , nella Chiesa dei santi Andrea e Procopio ( sopra, in foto ) è raffigurato in un affresco datato al XIV secolo : appare in abiti vescovili, aureolato e in posizione benedicente , con mitra e libro chiuso mentre sotto, sulla sinistra, è visibile quanto rimane degli attributi legati al mondo dei cavalli che lo caratterizzano ( tenaglia, martello, chiodi, ferro da cavallo e un mulo ) . Altre raffigurazioni del santo sono presenti nel tarantino, a Laterza nella chiesa rupestre di san Francesco ( affresco datato alla metà del XV secolo ) e nel leccese a Vaste, nella cripta dei Santi Stefani ( raffigurazione datata al XIV secolo ) e a Ortelle nella chiesa rupestre di santa Maria della Grotta, in un affresco postumo, datato al 1660.
Infine, annoveriamo la chiesa di Sant'Eligio a Bitonto ( sopra , in foto) . Fu consacrata nel 1299 dal vescovo Leucio ed era ubicata nell’attuale piazza Accademia degli Infiammati, nella parte nord-occidentale del nucleo antico, a poca distanza dall’antica Porta Rubastina, un’area fortemente urbanizzata in età angioina. Oggi la chiesetta è inserita in un edificio residenziale di età moderna. Tuttavia , restano leggibili alcuni elementi medievali databili tra il XIII e i primi decenni del XIV secolo: il profilo dell’abside su corte di Sant’Eligio, il portale, una minuscola bifora con capitello decorato da fogliame ( in foto, a sinistra) e un oculo. La chiesa custodiva il dipinto di Sant’Eligio che distrugge i falsi idoli, attribuito a Francesco de Corduba ( inizi secolo XVII ), poi trasferito nella chiesa di S. Maria della Porta. La devozione per il Santo si può rintracciare anche nella scultura in pietra del XVII secolo in corte Santa Lucia : il Santo in abiti vescovili, con ricco piviale decorato con motivi floreali, mitra e pastorale, regge il testo sacro.
Bibliografia
R. Bianco, Eligio, Martino e Giacomo. Santi d'Occidente nelle chiese rupestri pugliesi, in Puglia rupestre inedita, Archeologia, Arte , Devozione , M. Mignozzi, R.Rotondo ( a cura di ) , pp. 293 - 298, Adda, 2016;
R. Bianco, Culto e iconografia di sant’Eligio in Puglia tra Medioevo ed età moderna, in Studi Bitontini, pp. 7-26, Saggi, Edipuglia, 2013 -2014;
R. Bianco, Culto e iconografia di sant’Eligio in Puglia tra Medioevo ed età moderna, in Studi Bitontini, pp. 7-26, Saggi, Edipuglia, 2013 -2014;
S. Lusuardi Siena, Eligio, orafo e monetiere, estratto da Contributi dell'Istituto di Archeologia, vol IV, Università La Cattolica, Milano, 1973



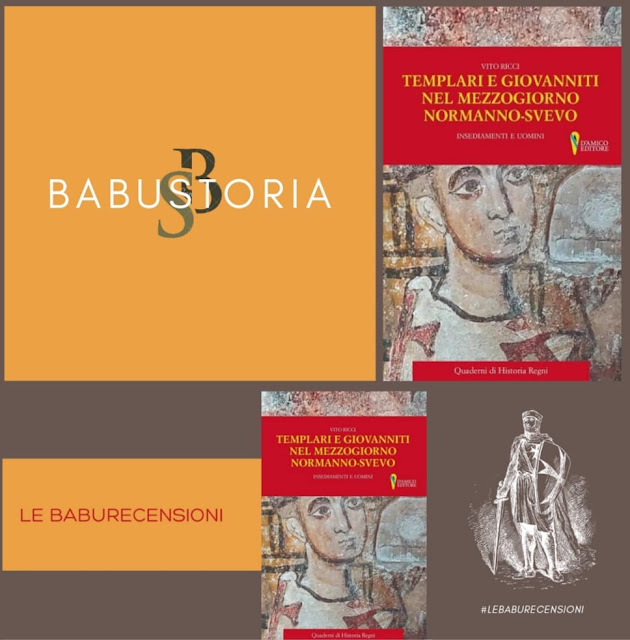

Commenti
Posta un commento