La prima cosa che notai furono i suoi lunghi, nerissimi capelli. Le incorniciavano il viso eburneo, scolpito dagli zigomi alti, illuminato dallo sguardo azzurro contornato da pesante matita nera. Pensai fosse una antica castellana dalla voce lirica e soave. Tarja Turunen , ex vocalist dei Nightwish , era favolosa nel lungo abito rosso sul set innevato di “Nemo” con quei capelli lucenti, lisci e corvini danzanti nel vento. Altrettanto memorabile fu il periodo biondo e incolto di Ozzy Osbourne, da perfetta “casalinga isterica”. Celebri i lunghi, indomabili capelli del chitarrista Zakk Wylde. Nel mondo del metal, così come della musica in generale, non è raro che gli artisti ( o i seguaci del genere) si lascino crescere i capelli per moda, appartenenza e, all'origine, contaminazione culturale o ribellione al sistema. Da amante del genere, le chiome lunghe e selvagge di cantanti e musicisti mi catturarono al pari della loro musica.
Ma nel Medioevo?
Che considerazione avevano i capelli?
 |
| San Nicola rifiuta il latte materno, dalle Storie di san Nicola, XI secolo, Novalesa (Torino) , cappella di Sant'Eldrado. |
Per rispondere a questa domanda vi invito caldamente a leggere Sulle teste nel Medioevo. Storie e immagini di capelli ( Il Mulino, 2021) di Virtus Zallot, docente di Storia dell'Arte Medievale e di Pedagogia e Didattica dell'arte all'Accademia di Belle Arti Santa Giulia di Brescia.
L'opera, un gustoso saggio di taglio accademico corredato di note e splendide immagini a colori, approfondisce lo studio dei capelli nell'arte, in qualità di importanti testimoni di un'epoca, di uno status sociale, di una mentalità o una inclinazione caratteriale.“ L'apparizione di una damigella bionda o l'incontro con un villano dai capelli corvini non potevano essere privi di conseguenze”. Bellezza e nobiltà erano distintivi dei soggetti biondi come i valorosi descritti da Geoffrey Chaucer nei Racconti di Canterbury. Se i rossi erano indice di singolarità fisica o , al contrario, malvagità, i capelli neri potevano essere associati al male se spenti ed opachi , virtù se brillanti e puliti come nel caso di Tristano dai capelli “ bruni ed arricciati in punta” , brillanti al sole. Bianchi per saggezza o per anzianità, principale attributo femminile , sono ancor oggi , in alcune culture , velati. Nel medioevo il velo era proprio delle maritate anche se più volte la Chiesa cercò di imporlo in generale a tutte le donne. Salimbene de Adam ci informa che per far fronte a questo problema le donne “ si facevano fare i veli di bisso o di seta , intessuti d'oro” risultando ancor di più appariscenti. La studiosa ci spiega la genesi di questa esigenza in virtù del volerne contenere la bellezza per “tutelare le donne da sguardi e desideri non legittimi e dal compiacimento che avrebbero suscitato , evitando nel contempo di sedurre gli uomini”.
I capelli simbolo di sensualità e di attenzioni non richieste erano i primi ad esser modificati con un taglio netto per sfuggire ad abusi, “pericoli o godere di una libertà preclusa”. Molto spesso il taglio della chioma poteva essere imposto ad esempio dopo un tradimento come fece il marito del fabliau Les Tresces oppure come si raccomandava nel Malleus Maleficarum nei confronti delle presunte streghe. Al contrario, erano oggetti di venerazione le ciocche dei santi come quelli di san Giovanni evangelista conservati ad Anagni. Ho trovato estremamente accattivante la narrazione di credenze e pratiche legate ai capelli di persone di Chiesa. Oltre che per contatto potevano sanare corpo ed anima se ingeriti come accadde alla novizia indemoniata guarita dopo aver ingurgitato le ceneri delle chiome della Badessa Rusticola ( VI – VII secolo). Le vergini o le sante, come Caterina ritratta dall'Aretino, portavano lunghe chiome come simbolo di castità a “guisa di velo”.
Se da un lato, il capo scoperto caratterizzava le vergini e le sante, dall'altro le donne più disponibili. “Sciolti e impudicamente esibiti erano causa e strumento del peccato”. Eva, Lilith e in generale il prototipo femminile più abietto aveva questa caratteristica, con le dovute eccezioni : Maria Maddalena li portava sciolti come simbolo di pentimento. Capelli curati, lavati, pettinati per vanità o per prepararsi ad occasioni importanti. Guai a perderli : dunque i rimedi per rinfoltirli o tingerli seguendo varie ricette tra cui spicca quella consigliata da Trotula a base di “corteccia centrale del bosso, fiori di ginestra , polvere di croco noto come zafferano maggiore, tuorli d'uovo”. Sino al XIV secolo le acconciature furono piuttosto semplici. Ornati con stoffa, nastri , ghirlande o semplici cordoncini trovano un degno esempio nella raffigurazione della madre di san Nicola in uno degli affreschi di sant'Eldrado a Novalesa ( XI secolo). Ho trovato particolarmente interessante il capitolo dedicato agli uomini. Nell'alto Medioevo specialmente in ambito barbarico la virilità violenta ed esibita era la norma. Sansone, dai lunghi capelli , rappresentava il modello ideale a cui aspirare. A dispetto delle femminili, nel medioevo le chiome maschili mutarono sia per taglio che per lunghezza. Ad esempio , alla fine del Trecento si diffuse la moda di arrotolarli in un boccolo sulla nuca come attestato nella raffigurazione dei 24 cittadini in fila verso il Bene Comune nell'Allegoria del Buon Governo del Lorenzetti.Attraverso le acconciature si esprimeva uno status oppure un’inclinazione morale. Il Diavolo, le sue schiere e i dannati si riconoscevano per le chiome scompigliate. Stessa connotazione avevano i selvaggi o coloro che per trascuratezza o scelta di vita (gli eremiti) avevano deciso di lasciarli incolti. Non avere capelli poteva essere un’onta incredibile o il segno della decomposizione. La riflessione sulle chiome porta la Zallot ad evidenziarne l'importanza legata alla gestualità: strapparsele dal dolore, ad esempio per un lutto. Questo gesto nell'iconografia tardomedievale riguarda anche gli angeli. “Se li strappano esprimendo in modo totalmente umano un dolore altrettanto umano per la morte di Gesù”. Si poteva afferrare per i capelli, impedendo una azione, immobilizzando o sollevando qualcuno di peso come nel martirio di santa Giuliana (XIV secolo) oggi esposto alla Galleria Nazionale dell'Umbria di Perugia.
 |
| Martirio di Santa Giuliana , XIV secolo, Perugia, Galleria nazionale dell'Umbria |
I capelli rientrano in questioni d'onore. I sovrani franchi Childerberto e Clotario, per evitare rivendicazioni dai figli del fratello morto, inviarono alla madre “una forbice e una spada sguainata”. O morti o con i capelli recisi. Per evitare la vergogna del taglio delle chiome, la madre preferì vederli morti. Se la rasatura femminile sciupava la bellezza, quella maschile la dignità e la considerazione sociale. Gli uomini di chiesa rappresentavano l'eccezione: mirabile è l'ampia chierica di san Domenico del Beato Angelico nel Convento di San Marco a Firenze (1438 – 1440). La tonsura, come confermato dalla Regola di Isidoro, distingueva il sant'uomo dal laico, il clero dai semplici cittadini. “A quanti sono deputati al sacro mistero s'addice la rasatura e la tonsura a forma di corona per il suo simbolismo” scriveva san Tommaso. Un caso a parte è la scotennatura, usanza delle tribù native americane e tortura biblica inflitta ad alcuni martiri cristiani, conosciuta anche nell'evo medio.
Ho adorato questo saggio sin dalla prima pagina. L'ho letto tutto d'un fiato: lo stile scorrevole rende la lettura accessibile a chiunque per studio, curiosità o semplice lettura. La narrazione della Zallot si prefigge di raccontare l'anima di un'epoca attraverso i capelli e non solo dal punto di vista della moda, ma anche della mentalità. Una descrizione completa capace di calarci in quei tempi lontani, riuscendo a viverli, comprendendoli meglio. Infatti, studiare e analizzare quei dettagli che fanno la differenza nell'approfondimento di un’opera è quel tipo di percorso essenziale senza il quale non si può comprendere un contesto, un periodo, un’ideologia diffusa. Per questo, credetemi quando affermo che la materia trattata dalla docente è estremamente accattivante e non solo in relazione all'epoca medievale in quanto si crea un forte ponte con l'oggi: capelli tagliati, tinti, rasati o pettinati in acconciature anticonvenzionali. Da sempre, i capelli ci caratterizzano, delineando non solo i tratti del volto ma anche le inclinazioni del nostro animo, la nostra volontà di conformarci o meno al sistema. Parlano di noi, delle nostre scelte e della moda del nostro tempo. Simbolo di avvenenza femminile, sono coperti ancor oggi da veli in alcune culture. Molti sono i ricordi legati ai capelli. Mia nonna racconta ancora i tempi della guerra, quando le povere donne, specie se giovani, erano costrette ogni volta ad abbruttirsi indossando abiti sformati, nascondendo le chiome sotto fazzoletti o cappucci mentre annerivano il volto con la cenere. Avere i capelli o...non averli. Per anzianità, malattia, calvizie o per volontà di altri. Il tentativo di atroce spersonalizzazione dell'individuo operato nei lager dal Terzo Reich partiva proprio da lì. Stessa cosa, per ripicca e disgusto, fecero i partigiani con le collaborazioniste nazi – fasciste alla fine del conflitto. È la storia di tutti noi perché come cantava Niccolò Fabi nel lontano 1997 “vivo sempre insieme ai miei capelli nel mondo”.
Sinossi:
Sulle teste nel Medioevo Storie e immagini di capelli
Un punto di vista del tutto inedito per raccontare abitudini, gusti, convinzioni che si sono sedimentati per secoli nel Medioevo occidentale. Scopriremo così che anche un gesto, un colore o un semplice taglio di capelli possono rivelare, a guardarlo bene, un passato secolare. Alessandro Vanoli.Uomini e donne con chiome lunghissime o con teste crudelmente rasate; vecchi orgogliosi della canizie o che la nascondono con la tintura; capelli esibiti o ripudiati, aggrediti o celebrati, trascurati o splendidamente acconciati; usati per sollevare, trascinare, trattenere e persino per volare. Al centro di gesti ordinari o straordinari, nel Medioevo i capelli indicavano la condizione sociale ed esistenziale, distinguendo il povero dal ricco, il buono dal cattivo, il vicino dallo straniero, il laico dal chierico, la donna onesta dalla dissoluta, la vergine dalla maritata, il vanitoso dall’umile. Questo libro li riscopre come inaspettati protagonisti di storie reali o immaginarie, tramandate dalla letteratura e dall’arte.
L'autrice: Virtus Zallot è docente di Storia dell’arte medievale e di Pedagogia e didattica dell’arte all’Accademia di Belle Arti SantaGiulia di Brescia. Studiosa di iconografia sacra, collabora con istituzioni culturali ed enti pubblici a progetti di ricerca e di valorizzazione del patrimonio artistico. Per il Mulino ha già pubblicato «Con i piedi nel Medioevo. Gesti e calzature nell’arte e nell’immaginario» (2018)
Dettagli: Autore: Virtus Zallot
Editore: Il Mulino
Collana: Biblioteca storica
Anno edizione: 2021
In commercio dal: 2 settembre 2021
Pagine: 288 p., ill. , Rilegato
EAN: 9788815293183


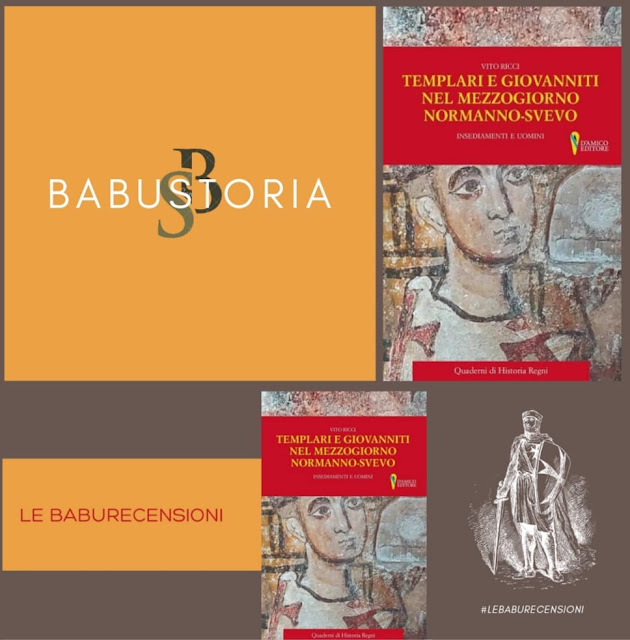

Commenti
Posta un commento