L'Unicorno
“Fantocci vivi! Adesso io crederò che esiston gli unicorni, che in Arabia v'è un albero pe'l trono della Fenice e che in quest'ora stessa la Fenice vi regna.”
Claudia Babudri
La storia dell'unicorno ha origine orientale. Sembra che la sua figura sia nata tra la Cina e l' India. In area cinese è celebre il K'i-in , animale mitologico dal carattere scontroso e dai poteri straordinari in grado di curare le malattie. In India le leggende alludono all’ antilope-unicorno o al pesce-unicorno, rappresentazione di Visnu . L’unicorno ritorna nel poema epico indiano Maharabata in cui l’eremita Rishyashringa ("Corno di Gazzella"), figlio di Ekashiringa ("Unicorno"), viene indotto a uscire dal suo rifugio dalla figlia del re. Nella tradizione mazdaica persiana, si parla di un immenso onagro bianco dall’unico corno e tre zampe: orinandovi, purifica l'oceano e cura dai mali.
Ma come arriva l’unicorno in Occidente?
Ctesia di Cnido, medico, storico e viaggiatore vissuto fra V e IV secolo a.C., compose l'Indikà . Era un trattato sull’India ,giuntoci in frammenti attraverso gli scritti del patriarca Fozio di Gerusalemme, nel IX secolo.
Nell'Indikà, Ctesia parla di un maestoso “asino selvatico”, probabilmente confuso con l’onagro o il rinoceronte incontrati chissà dove, forse in qualche esotica raffigurazione.
Posto tra le "meraviglie dell'India", l’unicorno fu studiato da molteplici dotti. Ad Aristotele, scettico sulla reale esistenza dell’animale, si contrappongono Plinio il Vecchio e, tempo dopo, Eliano : entrambi assimilarono l'unicorno al monokeros , ovvero il rinoceronte, per le imponenti dimensioni.
Fu Giulio Solino a unire tutte queste teorie dando vita, nella confusione generale, all’animale bello e mostruoso dal corpo di cavallo, la testa di cervo, le zampe di elefante, la coda di maiale e corno in mezzo alla fronte.
Alcuni autori medievali , al contrario, distinguevano il monokeros dall'unicorno , specificando che esso non è paragonabile neanche all'engliceron ( di minori dimensioni, dal carattere pacifico) o all'unicorno di mare (il narvalo). L’immagine odierna di questo animale è da ascriversi tra il XII e il XIII secolo: si passa dal mostruoso monokeros , al candido ed elegante cavallo bianco dotato di unico corno in fronte, spesso adorno di gemme preziose come quello descritto da Wolfram von Eschenbach nel Parsival .
_Le_Vue_(La_Dame_%C3%A0_la_licorne)_-_Mus%C3%A9e_de_Cluny_Paris.jpg) |
| Particolare da La Dame à la licorne, arazzo fiammingo del XV secolo |
Questo animale, furbo, orgoglioso, scontroso e violento, “tanto forte che è impossibile per i cacciatori catturarlo” ( Etymologiae, Isidoro di Siviglia), nemico giurato dell'elefante, era considerato preda d'eccezione per i cacciatori. Per stanarlo, si ricorreva ad uno stratagemma: sapendo che l'unicorno è attratto dall'odore della verginità, si lasciava una fanciulla nel mezzo di una radura. L'unicorno si sarebbe avvicinato spontaneamente per inginocchiarsi e porre il capo sul suo grembo. L'animale sarebbe stato ucciso a tradimento a meno che, fiutato il pericolo o la non verginità della fanciulla, uccisa l'esca e liberatasi, non si dava alla macchia. Se Richart de Fornival interpreta quest'episodio alla luce della casistica amorosa, questa vicenda è letta in senso cristologico nei Bestiari i quali attingono ai Libri dei Numeri, del Deuteronomio, dei Salmi, di Giobbe e di Isaia per l'accenno al re'em, una specie di grande bufalo, talora rappresentato come monokeros . Esso è Gesù Cristo , figlio della Vergine. Il suo grembo è la Chiesa. Il corno della creatura indica l'unità del Padre e del Figlio. Le virtù cristologiche dell'unicorno non sono accettate da tutti gli autori medievali. Infatti, nel XIII secolo, Pierre de Beauvais , Guillame le Clerc e Brunetto Latini concordavano sulla crudeltà dell'unicorno , figura diabolica impossibile da associare al Salvatore.
 |
Stemma con unicorno di Robert de Croÿ. Cambrai, Bibliothèque municipale, ms. 0012, f. 000Av. Gradual, 1540 (Francia Settentrionale o Belgio) |
Nell' araldica , mostri e animali fantastici tra ui quali l'unicorno, non sono molto frequenti, avendo un indice di frequenza non superiore al due per mille. Come tutti gli animali, anche l'unicorno poteva essere rappresentato per intero o nel particolare ( testa, profilo, zampe) , rampante o passante, saliente , corrente, seduto o coricato. Inoltre, a partire dal XIV secolo, come tutte le creature dell'araldica, poteva essere dotato di attributi ( corona, collare, catena) , con un oggetto tra le zampe e una parte del corpo colorata in modo diverso.
Bibliografia:
F. Cardini , L’Unicorno in Mostri, belve, animali nell’immaginario medievale/ 3, articolo pubblicato sulla rivista Abstracta n° 6 (giugno\luglio 1986), pp. 42-49.
M. Pastoureau , L'arte araldica nel Medioevo, Einaudi 2019.
M. Pastoureau, Bestiari del Medioevo, Einaudi, 2012

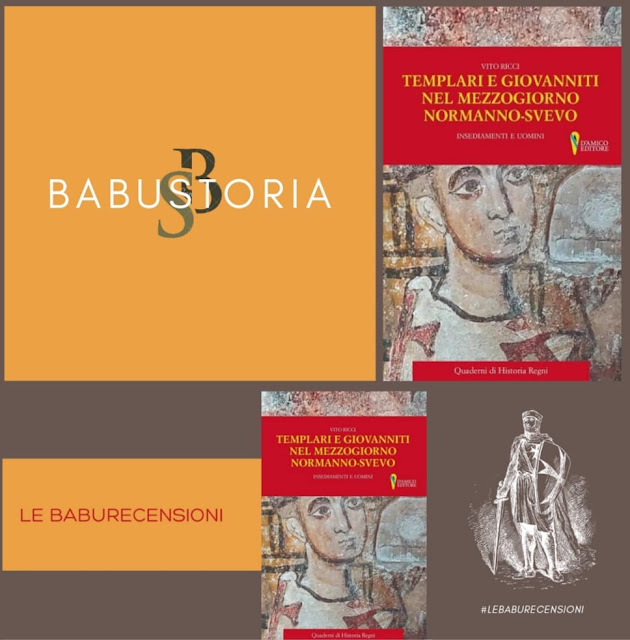

Commenti
Posta un commento