Sognare tra Antichità e Medioevo
Dormire: un toccasana, specialmente dopo una giornata impegnativa. Senza alcun dubbio, il sonno ha innumerevoli benefici. Aiuta a rigenerarci, riposarci e vivere meglio con i suoi effetti positivi su corpo e mente.

Giuseppe interpreta i sogni del faraone, mosaico, 1250 - 133o ca.,
Battistero di san Giovanni, Firenze.
Il sonno ha un rapporto strettissimo con la mente, specialmente se associata al concetto di anima, oggetto di studi e riflessioni sin dai tempi della Grecia antica. Al di là delle teorie filosofiche, è interessante riflettere sul rapporto tra anima e sogno, in relazione all’eternità e alla morte.
Spesso il sogno è il tramite attraverso cui i defunti parlano:
Tu dormi, e di me ti sei dimenticato, Achille […] Dammi una sepoltura al più presto, che io possa passare le porte dell’Ade…
Nel canto XXIII dell’Iliade, Patroclo appare in sogno ad Achille: la sua anima ha le stesse sembianze che aveva da vivo. Cerca attenzione dal grande guerriero per ottenere la degna sepoltura delle sue spoglie mortali mediante l’onore del fuoco. Nell’Odissea, la discesa tra il popolo dei sogni, ovvero l’Ade, dei Proci uccisi da Ulisse, è descritta come lo svolazzare disordinato di uno stormo di pipistrelli stridenti.
Le anime parlanti nei sogni risalgono ad antiche e primitive visioni. Un corpo senza anima è un fantoccio senza vita, abbandonato in uno stato di torpore momentaneo nelle quali l’anima è libera di vagare altrove. Ad esempio, in alcune regioni sudamericane come Brasile o Guyana, alcune tribù sono assolutamente convinte che sognare implichi vivere una esistenza alternativa. Ma attenzione! Guai a sognare troppo. L’anima potrebbe rimanere intrappolata, causando gravi malattie per il corpo e, in casi estremi, la morte. Presso gli Irochesi, popolazione di nativi americani originariamente stanziata tra gli attuali Stati Uniti d’America e il Canada, è celebre la Festa dei sogni. La durata delle celebrazioni è spalmata in diverse giornate in cui uomini e donne travestiti in varie maniere hanno libera licenza di essere fuori dai sensi e poter agire di conseguenza. L’unico modo di sfuggire a costoro è indovinare cosa hanno sognato.
Premonizioni, presagi e fantasmi. Per questo motivo, nell’Europa occidentale, la Chiesa medievale si oppose a queste superstizioni, salvando il generale concetto di sogno ritenuto positivo se contestualizzato nella rivelazione cristiana. Infatti, nel Deuteronomio (13, 1-4) si legge:
Se tra voi un profeta si leva a dire che ha avuto un sogno […] non ascoltare le parole di tale profeta o di questo sognatore, perché è Dio che così vi mette alla prova.
La considerazione del sogno nel Medioevo deriva dalla distinzione operata da Macrobio nel V secolo, in risposta al Somnium Scipionis di Cicerone. Macrobio dava diverso valore al semplice sogno, frutto della rielaborazione di una esperienza vissuta, rispetto all’oraculum, alla visio e al sommnium, ovvero le manifestazioni profetiche dello spettro onirico che ebbero grande influenza nell’Alto Medioevo. La Chiesa, durante questo periodo, si sincerò di distinguere i sogni veri derivati da Dio, dai falsi, figli di Satana. Di solito, i sogni accettati dalla Chiesa erano quelli chiari, privi di morti e apparizioni da ricercarsi tra le esperienze oniriche di qualità morale e sociale di monaci, sovrani o menti illuminate come quella del somniator Giuseppe il quale interpretò il sogno del Faraone d’Egitto, predicendo la carestia in arrivo.
Bibliografia:
J. Le Goff, L'immaginario medievale, Laterza 2007
James G. Frazer, Il Ramo D'Oro. Studia sulla magia e la religione, Bollati Boringhieri, 2013
Jean - Claude Schmitt, Medioevo "superstizioso", Laterza 2005
Questo articolo è comparso il 13 giugno 2021 sul Corriere di Puglia e Lucania
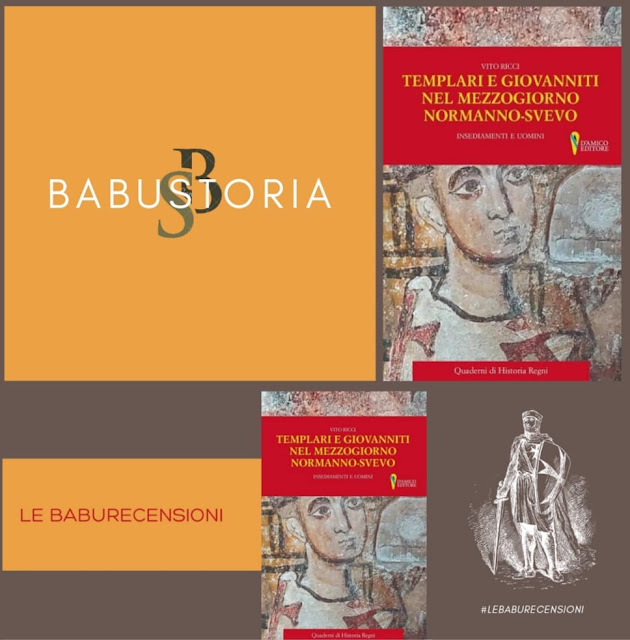

Commenti
Posta un commento