PRENDERE IL TORO PER LE CORNA: ICONOGRAFIA E STORIA DI UN SIMBOLO
 |
| Il toro, British Library, Royal MS 12 C. xix, Folio 32r |
Il significato di un simbolo:
Il sacrificio rituale di questo animale è presente nella discesa agli Inferi di Enea: l'eroe, munito di un ramo di vischio, si reca nell'Ade per interrogare il padre Anchise, il quale, bevuto il sangue del toro, potrà comunicare con lui. In altro contesto, la simbologia taurina torna anche nell'Esodo (XXIV, 4-8), nell'episodio in cui Mosè offre in sacrificio dei tori , banchettando con le carni, servendosi del sangue per benedire il suo popolo. Nell'Irlanda antica il sangue del toro aveva proprietà divinatorie. Infatti, secondo gli studi di Robert Graves, letterato inglese del XX secolo, questa usanza sarebbe attestata nel Lebor na hUidre (ovvero il Libro della Vacca Bruna), antico romanzo irlandese del XII secolo. Nell'opera, oggi custodita alla Royal Irish Academy, si menziona la "Festa del toro" in cui, sacrificato l'animale, mangiate le carni e bevuto il brodo ottenuto dal suo sangue, si cantava sopra la sua carcassa un incantesimo di verità al fine di scoprire, in sogno, la figura, l'aspetto e l'occupazione di colui che diverrà nuovo re. James Frazer, antropologo e storico delle religioni vissuto tra Ottocento e Novecento, racconta che in Madagascar, per evitare calamità e incidenti violenti, era consigliato portare "sulla testa un vasetto pieno di sangue sulla groppa di un toro". In Slesia, Boemia o Prussia, esso è simbolo di prosperità, incarnazione dello spirito del grano, sacrificato o invocato simbolicamente a fine raccolto sul campo della mietitura. Infine, nel Libro di Carmarthen , antica opera scritta interamente in gallese contenente eterogenei testi poetici (dal IX al XII secolo), l'eroe Gwyn è descritto come potente "toro della lotta" ovvero l'essenza maschile per eccellenza.
Nei Bestiari medievali, come studiato da Michel Pastoureau, storico e antropologo francese, il toro è famoso per la potenza sessuale (con i suoi genitali si preparavano rimedi per aumentare la virilità dell'uomo), la foga difficile da domare (attraverso la castrazione o strategie singolari come legarlo ad un fico, albero freddo, per neutralizzarne l'ardore) o il sangue che non si coagula. Come cavalieri in lotta per le dame, i tori combattono per le giovenche. Sono animali lussuriosi, strettamente legati al pagano (culto mitranico) che, i primi cristiani vollero distruggere e dissacrare dipingendoli come creature violente e lussuriose.
 |
| De Natura animalium, Ms. 711, folio 19r |
La storia dell'icona:
Ma è a Delfi e ad Olimpia che, tra VI e V secolo, l'immagine dell'eroe vittorioso sul toro fu perfezionata, "divenendo subito classica nel momento stesso in cui fu inventata". Il prode vincitore, ginocchio puntato contro il toro, ne afferra la testa mentre poggia l'altro piede a terra. A questo modello si rifanno le scene di Bellerofonte che doma Pegaso, del lapite che piega il centauro, o della Nike, dea della Vittoria, nell'atto di sacrificare un toro per celebrare la vittoria ateniese. Altra immagine è quella legata a Mithra, divinità indo-persiana che si diffuse in Mesopotamia, Grecia e poi Roma, divenendo molto comune tra i legionari. Oltre ad essere apprezzata perché potente raffigurazione del guerriero, Mithra era venerato in quanto protettore delle mandrie e dei raccolti. Per questo, era ritratto nell'atto di sacrificare un toro in una caverna, producendo fertilità, trasformando la coda dell'animale in spighe di grano. Mithra, divinità della Luce, porta il suo calore sulla terra in cui la bellezza del suo influsso è osteggiata dalla presenza malvagia di uno scorpione che punge i genitali del toro, avvelenandone la creazione. Il culto di questa divinità fu spazzata via da Costantino e dal Cristianesimo per riemergere, nel XII secolo, nell'iconografia di Sansone che vince il leone, simbolo del Cristo trionfante. La vecchia iconografia di Mithra fu ripresa nel Cinquecento come obiettivo di studio e ricerca prettamente archeologica.
Bibliografia di riferimento:
F. Saxl, La storia delle immagini, Roma Bari 2005, pp. 7-10;
M. Gimbutas, Il Linguaggio della Dea, Venexia, 2008, pp. 264-275;
M. Pastoureau, Bestiari del Medioevo, Einaudi, 2012, pp.131-133;
R. Graves, La Dea Bianca, Gli Adelphi, 201, pp. 120-121, 244, 256 - 257, 446;
J. Frazer, Il Ramo d'Oro, Bollati Boringhieri, 2013, pp. 468-557, 633, 548 - 551;
Virgilio, Eneide (libro VI), Oscar Mondadori, 1991.



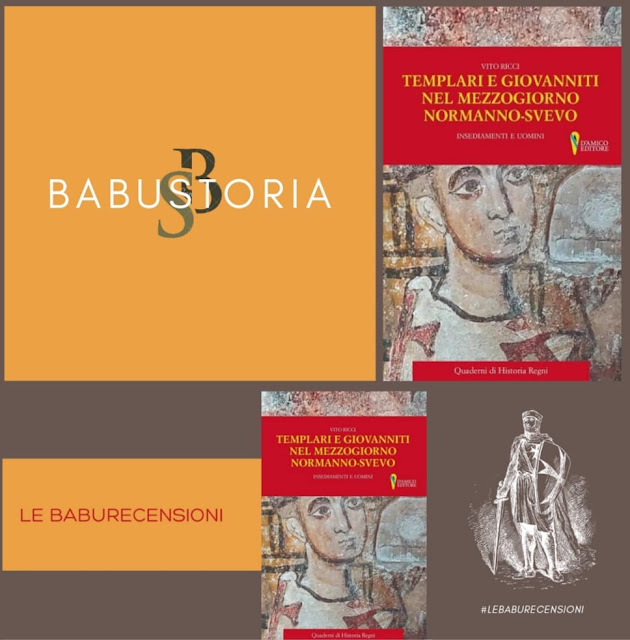

Commenti
Posta un commento