Speculum: la verità riflessa tra storia, cultura e buon governo
 |
| Libro d'Ore, Ms. Ludwig IX 5, Francia, 1410 circa |
Seppur controversi, gli studi di Jacques Lacan ci saranno utili per introdurre l'argomento di oggi: lo specchio. Infatti, secondo lo psicoanalista francese , nell'evoluzione umana è fondamentale lo "stadio dello specchio", ovvero una fase della vita compresa tra i sei e i diciotto mesi, importante per l'identificazione del sé. Per Lacan tutto inizia con lo specchio davanti al quale l'infante, in braccio alla madre, si riflette. Il bimbo, a questo punto, può riconoscersi nella figura riflessa (dopo aver incrociato lo sguardo della mamma, riconoscendo quell'immagine come sua) o continuare a ritenerla altro da sé (in assenza dell'incrocio di sguardi).
Quindi lo specchio, elemento fondamentale, diventa strumento di riconoscimento identitario, ritornando come importante cardine conoscitivo, difensivo e fantastico nella letteratura e nella mitologia.
In quella classica , Perseo utilizza uno specchio per difendersi da Medusa mentre nel pantheon shintoista la dea del Sole, Amateruso, impugna uno specchio sacro. Come simbolo di vanità, gli specchi sono utilizzati dalle sirene per ammaliare e confondere i marinai sulle navi.
Invece, guardandosi allo specchio, Vitangelo Moscarda, protagonista dell'opera pirandelliana "Uno, nessuno e centomila" , scopre la fastidiosa pendenza a destra del suo naso, iniziando a rivedere l'immagine del suo sé e l'integrità della sua identità. Ancor prima d'esser rivelatore di dubbi esistenziali o identitari, lo specchio è elemento divinatorio, oracolo nella "Biancaneve" dei fratelli Grimm e porta attraverso cui tutto si ribalta nel racconto "Throught the looking glass and what Alice saw there" di Lewis Carroll.
Rivelatore di un mondo nuovo spesso inquietante, lo specchio è anche collegato ad oscure dimensioni. Come suggerito dalla radice comune delle parole "spectrum" (spettro) e "speculum" (specchio), questo oggetto viene ancor oggi capovolto o coperto in alcune comunità contadine convinte che l'anima dei defunti possa rimanervi intrappolata e quindi non passare oltre, raggiungendo la pace. Al contrario, gli Andamanesi e gli Zulu africani credevano che l'anima coincidesse con la propria immagine riflessa negli specchi o nell'acqua.
Ma...nel Medioevo?
 |
| Liber astrologiae, Georgius Zothorus Zaparus Fendulus, T, f. 8v, 1401-1500 |
Tra le tradizioni curiose riferite agli specchi, ricordiamo l'usanza dei fedeli di ricavare auspici e pronostici dalla superfice aurea della patena, pratica largamente condannata dalla Chiesa. Utilizzato dalla medicina salernitana per la cura dei disturbi oftalmici, lo specchio riconferma in quest'epoca il suo ruolo divinatorio (come attesterebbe la storia dello specchio di Caterina dei Medici custodito nel castello di Chaumont-sur-Loire). La compagine oscura di quest'oggetto controverso, trova nella letteratura medievale il suo riscatto come simbolo di conoscenza e veicolo di verità con lo "Speculum", genere letterario composto da testi dedicati ai sovrani o a personaggi di rilievo, pregni di riflessioni e prescrizioni comportamentali ispirati ai più nobili ideali spesso di matrice cattolica.
Gli "Specchi dei principi" si diffusero maggiormente nel XIII secolo : nella sola corte francese di san Luigi furono composti ben cinque specchi destinati al re o ai membri della sua famiglia.
 |
| Salterio di Westminster, Royal 2 A. XXII, f. 219v, Inghilterra, circa 1250 |
Questo perché, come ricorda il vescovo inglese Giovanni di Salisbury parafrasando Guglielmo di Malmesbury, “rex illitteratus quasi asinus coronatus”. Il problema dell'educazione dei regnanti era infatti molto sentito, divenendo pressante specialmente con la trasformazione dei regni in Stati amministrativi e burocratici. Dalla seconda metà del XII secolo, si diffuse la sensibilità verso le maniere regie miranti a creare - come indicava l'espressione rexfacetus - il sovrano dai modi cortesi, incline all'umorismo istruttivo e di buon gusto. Ma il re deve essere anche e soprattutto colto, giusto, tendente all'umanità, pacificus (titolo che Bonifacio VIII attribuirà a Luigi IX detto il Santo). Insomma, il sovrano perfetto doveva avere un carattere che sfiorava il messianico. L'esempio più importante di "Specchio" è il Policraticus, scritto nel 1159 da Giovanni di Salisbury, filosofo, scrittore e vescovo inglese. Si tratta di un testo importante, testimonianza del cambiamento in atto dell'immagine del monarca. L'autore, attraverso esempi costruttivi tratti dalla storia greca e romana e dai precetti cristiani, delineava il re come un modello di comportamento, figura essenziale per creare una nuova società, rispettoso e timoroso della Chiesa, reso saggio e colto dalla conoscenza delle lettere e delle Sacre Scritture.
Bibliografia
A. Carotenuto, Il fascino discreto dell'orrore. Psicologia dell'arte e della letteratura fantastica, Bompiani, 2002
A.M. Di Nola, Lo specchio e l'olio. Le superstizioni degli italiani, Laterza, 2018
Giovanni Di Salisbury, Policraticus, Jaca Book, Milano, 1985
J.G. Frazer, Il Ramo d'Oro. Studio sulla magia e la religione, Bollati Boringhieri, 2012
J. Lacan, Lo stadio dello specchio come formatore della funzione dell'Io, XVI Congresso internazionale di psicoanalisi, Zurigo, luglio 1949.
J. Le Goff, Il re medievale, Giunti, 2012
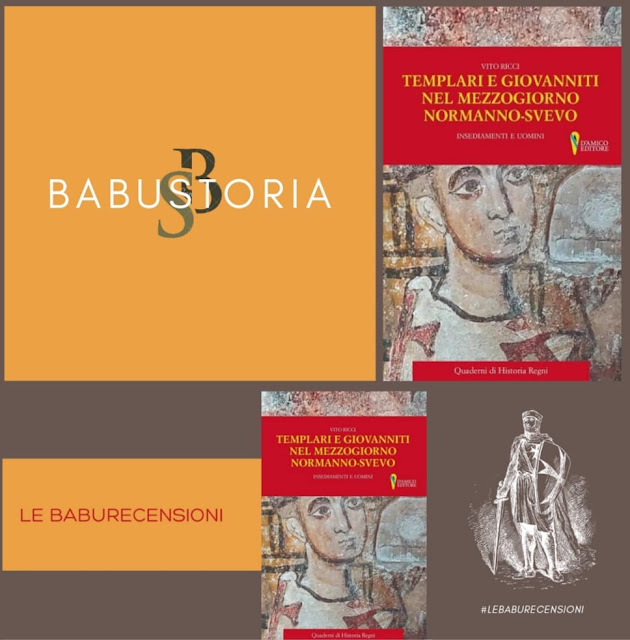

Commenti
Posta un commento