Ambivalente e complesso: Giallo
Insomma, il giallo incarna pregi ma anche difetti. Ma da dove nasce questa ambivalenza?
 |
| Statua di una matrona (circa 100-110 d.C.), Gliptoteca di Monaco di Baviera |
Il giallo nell'Antichità
Per i pittori del Paleolitico, l'ocra gialla era facile da reperire, dalla tenuta stabile e per nulla tossica, composta
Anche se è prematuro parlare di simbologia del colore, possiamo affermare che in Occidente, durante il Neolitico e l’età dei metalli si stabilizzano i primi referenti lessicali del giallo legato all'oro, metallo divino, protagonista di molte storie e mitologie, in primis quella greca e romana. A Roma si conosceva il giallo e si avevano vari aggettivi per definirlo. Ad esempio, per indicare i capelli biondi dei Romani e dei Greci si usava il frequente "flavus" sostituito dai dispregiativi "luridus", "pallidus"
A questo proposito, ricordiamo che a Roma i tintori, uniti in corporazioni
Ma, si domanda a questo punto Michel Pastoureau, il giallo e l'oro compaiano nella Bibbia? Se
 |
| Insegne recanti arme nella Wappenrolle von Zürich (Zurigo, ca. 1330-1335). Zürich, Musée national suisse. |
Il giallo nel Medioevo
Quindi, cosa succede tra VI e XV secolo?
Il codice liturgico cristiano rimase privo del giallo per tanto tempo a causa del lungo silenzio della Bibbia e dei Padri della Chiesa sull'argomento. In effetti, agli inizi, gli officianti del rito cristiano vestivano di bianco o di tessuti non tinti. Con il passare del tempo, il bianco fu sempre più utilizzato nelle feste solenni come la Pasqua, accompagnato a partire dal IX secolo dall’oro e colori saturi e brillanti giustificati da un buon numero di trattati speculativi sul cromatismo liturgico che, "spesso anonimi e difficili da datare, se non da comprendere" non si sa se "abbiano avuto qualche impatto sulle pratiche del culto reali" ma i cui contenuti vengono ripresi dai grandi liturgisti del XII secolo .Verso il 1195, il cardinale Lotario, futuro Innocenzo III, scrisse il De sacro sancti altaris mysterio, opera giovanile, nella quale l'autore descrive le usanze della diocesi romana (consuetudini diventate legge per l'intera cristianità nel XIII secolo), tra le quali figurano anche le descrizioni di abiti e colori utilizzati durante la liturgia...tra questi, ancora non figura il giallo, il cui caso " lascia perplessi tutti i liturgisti e i teologi: da una parte, la Bibbia e i Padri non ne parlano e la sua simbologia è pressoché inesistente; dall’altra, è onnipresente l’oro, che ha funzione di colore nel completare la tavolozza liturgica basata su rosso, bianco, nero e verde. Sul piano scritturale come su quello materiale, il giallo non trova posto".
Per avere una panoramica più chiara sulla progressiva diffusione del sistema dei colori liturgici fra l’epoca carolingia e il XIII secolo, l'archeologia e la liturgia hanno bisogno dell'araldica nella quale "per la prima volta al giallo viene attribuita una simbologia propria, indipendente dalla materialità e dal supporto".
Infatti, è con la comparsa degli stemmi nel XII secolo che a questo colore vien dato un posto di rilievo, passando da tre colori di base (bianco, rosso, nero) a sei (bianco, rosso, nero, verde, giallo, blu). "Sui campi di battaglia e nelle arene dei tornei, poi nella società nel suo insieme" scrive Pastoureau "gli stemmi si compongono di due elementi per affermare l’identità e segnalare la proprietà: figure e colori, collocati in uno scudo delimitato da un perimetro" obbediscono a poche ma stringenti regole di composizione in primis riguardanti i colori.
Nell'araldica, il giallo si intende "come colore astratto, e non più solamente tanti gialli che variano secondo il pigmento, il colorante, la luce e la tecnica". Insomma, non importano le sfumature ma l'idea del giallo e non la sua rappresentazione materiale.
Il giallo negli stemmi è oro, colore chiaro, forte e lucente come il sole, nobile e pieno di virtù. Simboleggiato dal leone e associato alla domenica, il giallo è capace di infondere conforto, tanto che i medici "consigliano di mostrarlo ai malati più deboli e in fin di vita, affinché restituisca loro le forze".
A proposito di stemmi e di cavalieri, un topos narrativo che ricorre nei romanzi arturiani dei secoli XII e XIII (in versi e in prosa) è la comparsa di un cavaliere sconosciuto munito di un’arme monocroma il cui colore ne suggerisce le intenzioni: un cavaliere nero è un personaggio buono e di primo piano che cela la sua identità, al contrario di uno rosso e demoniaco. Se il cavaliere bianco è il saggio e anziano amico o tutore del protagonista, il cavaliere verde è il giovane audace di recente investitura. Ma il cavaliere giallo? Si tratta di una figura ambivalente, ora generosa e prodiga d'aiuto, ora traditrice. Il colore indossato dal cavaliere diviene spia del significato che questo colore assunse nei trattati e nei manuali d'araldica risalenti al Tardo Medioevo. Ma non solo. Come nell'antichità erano bionde alcune divinità, nel Medioevo i capelli di questo colore sono simbolo di nobiltà, onore, cortesia, bellezza e amore di chi li porta: Isotta era bionda al contrario della mora (perché adultera) Ginevra.
 |
| Bacio di Giuda, particolare, Giotto, Cappella degli Scrovegni, Padova, XIV sec |
Il lato oscuro del giallo
A proposito del cavaliere giallo si parlava dell'ambivalenza di questo colore che da una parte rappresenta la nobiltà dell'oro, dall'altra si rifà a più bassi concetti, legati ad esempio alla lordura e alla malattia in riferimento alla bile o all'urina. Inoltre "dalla fine del XIII secolo, la simbologia del giallo si degrada molto, evocando di volta in volta l’invidia, la gelosia, la menzogna, il disonore e il tradimento". Il numero dei vizi associati al giallo crescono sempre di più alla fine del Medioevo. Il giallo diviene simbolo di invidia in quanto, nel corso del XIII secolo, con l’elenco dei sette peccati capitali, all'invidia viene attributo questo colore. Ragionando poi sull'instabilità chimica dei pigmenti gialli, gli vengono attribuiti anche l'inganno e la menzogna e poi il tradimento. Ad esempio, nel Roman de Renart, l'omonima protagonista, una scaltra volpe in fuga dalle guardie del re Noble (il leone), s’intrufola nel laboratorio di un tintore, cadendo nella vasca del giallo. Con uno stratagemma truffaldino, l'astuta protagonista riuscirà ad ingannare il tintore solo per farsi aiutare. Come si accennava, dal colore della falsità e della menzogna, il giallo è diventato anche colore dell’eresia e del tradimento, legame evidenziato anche "da una pratica spettacolare che, tra la fine del Medioevo e l’inizio dell’età moderna, consiste nel tinteggiare di giallo la casa di una persona in vista che si sia resa colpevole di alto tradimento, eresia o lesa maestà". Su questa falsariga ci spieghiamo perché a Costanza, nel 1415, Jan Hus, colpevole di essersi ribellato all’autorità dell’imperatore e alla supremazia della lingua tedesca, fu portato al rogo vestito di giallo.
 |
| L'Ultima Cena, Salterio (Baviera?, ca. 1230-1240), Melk (Austria), Stiftsbibliothek, Cod. lat. 1903, fol. 11v. |
Il giallo del tradimento
Anche i nemici di Cristo indossano abiti gialli alla stregua di colui che lo ha tradito: Giuda. Rosso di capelli per sottolinearne l’indole falsa e perfida, è abbigliato di giallo per indicare l'appartenenza alla stirpe ebraica e il suo tradimento. Michel Pastoureau precisa che "né i testi canonici del Nuovo Testamento né i vangeli apocrifi descrivono l’aspetto fisico di Giuda o il suo abbigliamento durante l’arresto di Gesù. Di conseguenza la sua immagine nell’arte paleocristiana e del primo Medioevo non si caratterizza per tratti o attributi specifici."
La necessità di distinguere Giuda nasce dal bisogno di rappresentarlo in maniera precisa nella raffigurazione dell' Ultima Cena, differenziandolo per posizione, statura o atteggiamento. Il primo tratto distintivo di Giuda nasce nei paesi del Reno e della Mosa in epoca ottoniana: i capelli rossi e poi anche la barba dal XII secolo. Dal Duecento invece, Giuda veste di giallo. "A volte" precisa Pastoureau " gli si aggiunge un tocco di verde per sottolineare la sua cupidigia, essendo il verde, nel Medioevo, il colore dell’avarizia (il che mette anche in risalto la borsa coi trenta denari). I due colori si associano quindi sotto forma di una veste a righe o bipartita, oppure di una veste gialla e di un mantello verde. Ma questo avviene raramente. Più spesso, l’apostolo traditore indossa una grande veste gialla monocroma, e in molte miniature, vetrate o tavole è l’unico a portare quel colore, contribuendo in tal modo a sminuirlo".
La riflessione che deriva dall'utilizzo di questo colore genera domande interessanti come la seguente: il giallo ha cattiva reputazione solo nel simbolico o anche nel reale? "Non è facile rispondere" rivela Pastoureau " ma sembrerebbe che sul finire del Medioevo e agli inizi dell’età moderna il giallo sia meno frequente nel vestiario di quanto non lo fosse in epoca feudale o a metà del XIV secolo".
Prendiamo la Prammatica del vestire fiorentina, opera del XIV secolo in cui si elenca il guardaroba delle nobildonne fiorentine. Questo inventario, fu stilato da molti notai per consentire la concreta applicazione delle recenti leggi suntuarie che prevedevano sia la tassazione dei beni di lusso considerati investimenti improduttivi sia la lotta alle nuove ed eccentriche mode, insistendo sulla necessità di abbigliarsi come status e rango comandavano. Insomma, dall’autunno del 1343 alla primavera del 1345 ogni fiorentina della buona società doveva denunciare il proprio corredo al notaio del quartiere. La Prammatica contiene 3257 notifiche "per recensire 6874 vesti e mantelli, 276 ornamenti per il capo, un gran numero di accessori di ogni genere, il tutto appartenente a oltre 2420 signore, alcune delle quali compaiono più volte" tra cui predomina il colore rosso, seguito dalla tonalità gialla.
Le dame fiorentine, come quelle delle altre grandi città in Italia, Francia, Germania o Inghilterra, ancora amavano abbigliarsi con questo colore attorno agli anni quaranta del XIV secolo, alla vigilia della Peste nera. Questo trend durerà ancora per poco : nei secoli successivi, il giallo non sarà più un colore di moda, ricercato dalle donne eleganti, destinato ad essere relegato al vestiario femminile delle classi contadine, scomparendo progressivamente dall’abbigliamento cittadino e, dalla fine del XIX secolo, dall’abbigliamento in genere.
M. Pastoureau, Medioevo simbolico, Laterza, 2019
M. Pastoureau, Giallo, Ponte alle Grazie, 2023

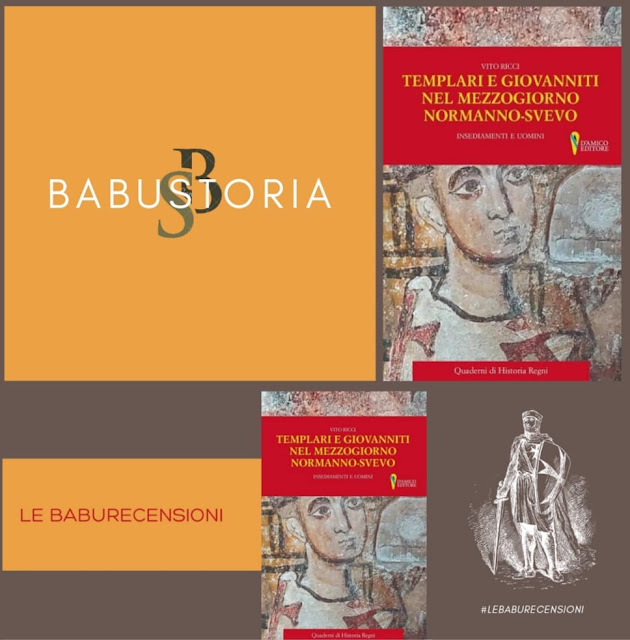

Commenti
Posta un commento