 |
Il Tempietto di Seppannibale
|
Il
Tempietto
di Seppannibale
( VIII
sec d.C ), originariamente chiesa
di San Pietro lo Petraro , si
trova a 3
km da Fasano (BR) ,
sulla strada per Monopoli.
E' ubicato nelle vicinanze dell'area archeologica di
Egnazia,
importante centro portuale di età romana e tardo antica. Si tratta di una costruzione a pianta quadrangolare , a tre navate interne, con due cupolette disposte in asse. All'interno , vi sono i resti di affreschi di alcuni pittori della scuola beneventana. Quelli tuttora visibili, per quanto frammentari, mostrano alcune figure (forse Profeti) e scene tratte dal libro dell'Apocalisse. Nel Settecento, Giuseppe
Annibale Indelli
, proprietario della masseria contigua al Tempietto, diede al Tempietto il nome odierno.
Negli anni
Novanta
del secolo scorso ,
fu Gioia
Bertelli,
docente di archeologia
paleocristiana e
altomedievale presso il dipartimento di studi classici e cristiani
dell'Università
degli Studi di Bari,
a curarne le indagini archeologiche, studiando le tracce dell' abitato
tardo antico,
attivo tra il IV
e l'VII secolo, ritrovato nella zona antistante.
 |
Il ritrovamento sacrificale
|
Le strutture tardoantiche si
appoggiavano ad alzati di età
precedenti
(molto probabilmente di età
romana,
dato il ritrovamento di monete afferenti al tempo di Vespasiano,
Antonino
Pio
e
Commodo).
Altrettanto interessante , al di sotto dell'edificio , il
rinvenimento di tracce di muratura, forse
un recinto sacro in virtù della scoperta di una lucerna e resti animali. La datazione è afferente con approssimazione all'inizio
dell'impero.
 |
Particolare del ritrovamento sacrificale
|
Le campagne di scavo:
 |
Posizione geografica del sito
|
Ben quattro
campagne di scavo,
dal
2003 al 2006, si sono interessate al sito, con cinque
saggi stratigrafici, ovvero cinque fasi stratigrafiche e temporali:
 |
Localizzazione, planimetria e prospetti del sito
Rispetto alla chiesa, il saggio I ( con sepolture a fossa terragna) , lungo il lato settentrionale ed orientale, corrisponde alla frequentazione più antica del sito. In questa fase , la scarsa presenza di ceramiche , ne ha escluso la funzione abitativa e l’assenza di crolli di laterizi ha permesso di ipotizzare che l’area delimitata dalle strutture murarie fosse scoperta. Utilissimo, al fine della datazione del saggio I , è stato il rinvenimento di origine rituale e sacrificale , dei resti di due ovo-caprini, adiacenti tra loro, posizionati nell’angolo tra uno dei setti murari intenzionalmente sigillati con grossi blocchi di pietra. Tra i due, quello più ad est era acefalo: la sua testa staccata e posizionata al lato del corpo, presentava in bocca un chiodo e una moneta di bronzo raffigurante l’imperatore Tito . Accanto, il rinvenimento di una lucerna. Il saggio I , databile tra l’età repubblicana e quella imperiale (III sec. a.C. - prima metà del I sec. d.C.) ha restituito una struttura costruita con grandi blocchi di calcarenite, adibita alla produzione agricola (probabilmente una fattoria) con vasca quadrangolare vinaria all'interno. Il rito sacrificale, rinvenuto a ridosso della struttura agraria , va ascritto alla fine del I e inizi del II sec d.C. II . Il saggio II, collocato come
il V
ad
ovest,
presenta diverse strutture a carattere abitativo, produttivo e di
stoccaggio delle derrate ( ad esempio un silos
). Sono stati individuati, inoltre, anche resti di strutture più
imponenti, a
pianta longitudinale. In questa fase, sorse un abitato che visse
fino
all’età
altomedievale, edificato su un precedente contesto forse databile
ai primi secoli dell’impero dal ritrovamento di una altra lucerna e una moneta di età antoniniana.
Ricapitolando: in
epoca
tardoantica
l’impianto
produttivo
viene
dismesso
e sull’area abbandonata si costruì un
insediamento
rurale,
composto da piccole unità
abitative con una più imponente
(IV
e il VII sec.
d.C). Se il saggio
III,
a nord,
ha riportato solo scarse tracce di frequentazione relative a tempi
molto recenti (XVI sec. d.C.) e il saggio IV, a sud, la
presenza di alcune buche poco profonde, ,probabilmente
forni per la produzione della calce ad alte temperature, il saggio V , ad ovest, ha riportato alla
luce sepolture parzialmente integre determinando l’uso funerario
di quest’area. Dunque, nell’VIII
secolo fu eretto il
Tempietto
e il vecchio abitato rurale, oramai abbandonato, fu sostituito
dal suo cantiere . La frequentazione
funeraria,
riscontrata a ridosso della chiesa e datata al’XI-XII
secolo,
fa pensare alla presenza di una piccola
comunità
che
gravitava
attorno
al
Tempietto. |
Materiali e tecniche costruttive:
 |
Particolare degli affreschi del Tempietto
|
Il Tempietto è una testimonianza preziosa non solo per lo studio storico, archeologico e culturale del territorio ma anche per la bellezza e composizione delle decorazioni superstiti ubicate in prevalenza sulle volte , all'interno della costruzione.
Attraverso un approfondito studio
analitico è stato possibile conoscerne la
composizione di intonaci e colori :
rosso
(ocra rossa, costituita da silico-alluminati e ossidi di ferro) ,
giallo
( un’ocra gialla, costituita da silico-alluminati e da idrossidi
di ferro), bianco
( bianco di calce), grigio
e nero
(nero di vite, variamente miscelato con il bianco, talvolta con l’ocra per il
colore nero). Dalla miscela di questi due pigmenti risulta
anche una tonalità
bluastra.
I bassi
capitelli dei pilastri centrali
a sostegno delle cupole sono realizzati con una roccia
locale
appartenente alla formazione cretacica nota come “Calcare
di Bari”.
Purtroppo, pur avendo subito un significativo intervento di restauro
negli
anni Ottanta del secolo scorso,
le pitture del Tempietto mostrano alcune manifestazioni di
degrado,
rappresentate prevalentemente dalla presenza di veli
biancastri
e da depositi
di guano.
 |
Veduta absidale del Tempietto
|
Ribadiamo infine l'importanza del sito nell'ambito delle aree
rurali
( come per esempio il vicus di Vagnari,
vicino Gravina di Puglia) e della tradizione costruttiva tra
età imperiale e Tardoantico che
prevedeva abitati realizzati con uno
zoccolo in pietra calcarea e alzati in materiale deperibile.
Seppannibale riprone la tematica del riuso delle ville romane in forme abitative diverse sia nella concezione planimetrica sia nella scelta dei materiali, riflessione nata in relazione alle indagini effettuate in
un altro sito importante, quello di Faragola.
In generale, tra
VI e VII secolo d.C,
l'area di Seppannibale presenta una discontinuità architettonica ,
un minor uso dei materiali lapidei ( già
a partire dal IV sec. d.C )
dovuta ai mutamenti
economici del territorio e del Mediterraneo. Infatti, il
tracollo delle attività estrattive e il duro contraccolpo sui ceti
medi
, ne causarono l'estinzione
dei maestri specializzati a
vantaggio di nuove
tecniche costruttive basate sull'utilizzo di mattoni di argilla cruda
( pisè) e legno.
L' occhio del
pittore:
 |
Tempietto di Seppannibale,
albero lungo la navatella settentrionale |
Cosa c'è di più determinante per la rappresentazione della realtà
in cui una società vive? Ovviamente il contesto
considerato in tutte le sue sfaccettature ( economico, sociale,
naturale). Esso è linfa per l'ispirazione e per la
rielaborazione artistica da parte di un popolo. Seppannibale è
un valido esempio in questo ambito per i suoi importanti dipinti (
VIII secolo) . A differenza del mondo antico, il Medioevo non
ha una ben consolidata tradizione di studi iconografici sugli
elementi vegetali. A questo proposito , il contributo di G.
Colaianni evidenzia come la vegetazione dipinta
nel Tempietto non solo sia mirabile frutto delle capacità
espressive ed interpretative da parte dell’uomo nei
confronti della natura nel suo tempo, ma rappresenti
inoltre un ottimo esempio per colmare quel vuoto sugli studi
sulla vegetazione nel medioevo, fornendoci la raffigurazione di
fiori e piante diverse che consentono di
ricreare parte del paesaggio
rurale nell'area delle Murge baresi
in età altomedievale. Vediamo
insieme quali sono le immagini di maggior interesse. Diciamo in
primis che quasi tutte le scene affrescate presentano un campo
biancastro con pennellate orizzontali di color giallo - ocra.
 |
Tempietto di Seppannibale, papavero comune
|
Nella prima cupoletta tal motivo è leggibile non solo
sui fondi delle tre nicchie dove campeggiano due martiri
e un diacono ma anche sulle sue pareti curve . Guardando
verso ovest, sotto una figura maschile della quale rimane
solo un piede posto su un suppedaneo, troveremo un campo
giallo con fiori rossi ( che
per struttura, lunghezza e portamento del fusto e per le foglie
dal contorno spatolato, si è ipotizzato essere papaveri comuni,
ampiamente diffusi in Italia e ritrovati artisticamente in molti cicli lucani,
campani e molisani databili tra la fine dell’VIII secolo e i primi
decenni del successivo ) . Ad est tale rappresentazione
vegetale occupa tutta la parte inferiore della scena della
Donna alata insidiata dal drago apocalittico.
 |
Tempietto di Seppannibale, pianta dai frutti rossi
|
Nella seconda cupoletta, prendendo in considerazione il
muro dell’arcata meridionale sono affrescati due pavoni
raffrontati, intenti ad abbeverarsi ad una coppa ( cantharos
) e una grande pianta con frutti dal colore rosso scuro.
Non si tratta di un fico d'India (approdato in Occidente dopo la
scoperta delle Americhe) ma di un altro tipo di vegetale,
rielaborato e ridipinto dal pittore con fiori rossi per motivi
sconosciuti. Gli studi effettuati sul cromatismo della
raffigurazione, hanno inoltre permesso di distinguere in quest'
unica composizione tre piante diverse , in parte
sovrapposte.
Lungo la navatella settentrionale spicca un altro vegetale ,per struttura e colore dei frutti definito gelso nero, pianta di origine
caucasica , tipica anche del nord della Persia, giunta in Italia in
epoca repubblicana (Plinio , Nat. Hist. XV, 27) e diffusasi ampiamente a partire dal 552 con la spedizione in
estremo Oriente organizzata da Giustiniano per acquisire nuove tecniche di produzione della seta ( Procopio da Cesarea , De Bello Pers. I, 20).
Furono poi gli Arabi a diffondere la sericoltura in tutto il
bacino del Mediterraneo a partire dal IX secolo. Il
gelso nero fu progressivamente
sostituito durante il
XV secolo
dal gelso bianco
( proveniente dalla Cina e dal Giappone) per via delle sue foglie
meno coriacee e, dunque, maggiormente apprezzate dai bachi da seta
come nutrimento.
Le lucerne:
 |
Tempietto di Seppannibale, lucerna di tipo
Fabbicotti ff b rinvenuta nel contesto sacrificale |
Le lucerne rinvenute dal sito di Seppannibale sono in tutto
sessantatré, molte delle quali rinvenute in condizioni frammentarie. Di queste totali,
solo quarantadue sono state schedate e catalogate in crono - tipologie :
- lucerne a vernice nera di età tardo-repubblicana
- lucerne italiche di età imperiale
- lucerne africane di età tardoantica
- lucerne invetriate di età medievale
I dati analitici di questi reperti, uniti agli studi recenti sui
commerci
nel mediterraneo in età
tardo
antica,
consentono di affermare che le lucerne
d’importazione o in sigillata sono state sicuramente prodotte sulle
coste settentrionali della Tunisia.
La
diffusione
di
questi
prodotti
nell’insediamento
di Seppannibale
è avvenuta probabilmente
attraverso
i carichi
navali provenienti dalle coste africane e
mediterranee diretti nei porti pugliesi, come Egnazia.
Accanto a questi manufatti vanno aggiunte le tipologie ad impasto locale, fatte in loco, realizzate probabilmente
seguendo il modello tunisino di importazione. Per quanto riguarda le
lucerne in sigillata si riscontrano decorazioni di tipo
geometrico e fitoforme. Quelle locali , di qualità meno pregiata, presentano un numero
maggiore di elementi geometrici e fitoformi insieme
a simboli religiosi e soggetti zoomorfi.
 |
Tempietto di Seppannibale, lucerna con Menorah
e sua ricostruzione grafica
|
Tra tutte, è interessante una lucerna di produzione
locale, databile
al
V secolo d.C.,
riportante sul
disco
la Menorah
ebraica
( lampada
ad olio a sette bracci
) all’interno di una corona vittata . Probabilmente, più che per
l'illuminazione tale lucerna veniva utilizzata con
uno scopo rituale all’interno
delle sinagoghe . Potrebbe trattarsi di un oggetto
ad uso liturgico, riprodotto a Seppannibale, utilizzato nelle
comunità
ebraiche
pugliesi,
come quelle di Bari,
Oria
e
Taranto che
in età
tardoantica erano
vicine al tal sito. Ma c'è una altra considerazione da
fare. Dall'ampia analisi di lucerne simili rinvenute dalle
necropoli situate in una area più grande (Venosa,
Siracusa,
Noto,
Quartucciu, il complesso martiriale di Cimitile, il sito urbano di Egnazia e gli insediamenti rurali di Seppannibale,
Leucopatra (presso Reggio Calabria), e il materiale dei musei archeologici di
Taranto
,
Reggio Calabria,Oristano,Cagliari
e
Sassari),si evince che queste lucerne avevano uso
funerario poichè venivano ubicate presso le sepolture di cimiteri
sia totalmente ebraici che misti! Dunque, se da un lato la Menorah
è il simbolo per eccellenza della religione ebraica, dall’altro la
sua diffusione nell’apparato decorativo delle lucerne non è sempre
relativo a tal culto.
Analisi e ricostruzioni 3D
 |
Restauro virtuale degli affreschi
|
Insieme all'analisi
stratigrafica del sito, il professor M. Limoncelli ha
realizzato un restauro virtuale in 3D del Tempietto nella
sua fase altomedievale, utile non solo per ricostruire la struttura
ma anche per sintetizzare , visualizzare, spiegare e verificare le
analisi e le ricerche condotte attraverso questo prezioso strumento informatico, previo rilievo grafico in sito andando a
risarcire virtualmente le parti mancanti, valorizzando
telematicamente le analisi e le scoperte effettuate attraverso la
ricostruzione virtuale.
 |
Restituzione 3D del Tempietto
|
Bibliografia e immagini :
A. Attolico, Alcune
riflessioni a margine dello studio del villaggio di Seppannibale :
l'edilizia in materiale deperibile in Puglia tra Tardoantico e
Altomedioevo, in VI congresso Nazionale di Archeologia Medievale,
Sala Conferenze "E. Sericchi", Centro Direzionale CARISPAQ
"Strinella 88", Società degli Archeologi Medievisti
Italiani, L'Aquila, 12 – 15 settembre 2012, All'Insegna del Giglio,
pp. 121- 127.
A. Calia, D. Melica,
G. Quarta, I dipinti murali del Tempietto: materiali costituenti e
tecniche esecutive, in Masseria Seppannibale Grande in agro di
Fasano (BR). Indagini in un sito rurale (aa. 2003-2006), G.
Bertelli , G. Lepore ( a cura di) , M. Adda Editore, 2011 , pp. 195
-206.
G.Bertelli,
Il
tempietto di Seppannibale in territorio di Fasano,
in Società,
cultura, economia nella Puglia medievale,
atti del convegno di studi "Il territorio a sud-est di Bari in
eta medievale" (Conversano, 13-15 maggio 1983) a cura di Vito
L'Abbate. Dedalo, Bari 1985, pp. 235–276.
G.
Bertelli, Cultura longobarda nella
Puglia altomedievale: il tempietto di Seppannibale presso Fasano,
con uno studio epigrafico di Giuseppe De Spirito; rilievi
fotogrammetrici di Maurizio Minchilli, Edipuglia, Bari, 1994.
G.
Colaianni , Lettura iconografica della decorazione vegetale del
Tempietto, in Masseria
Seppannibale Grande in agro di Fasano (BR). Indagini in un sito
rurale (aa. 2003-2006),
G. Bertelli , G. Lepore ( a cura di) , M. Adda Editore, 2011, pp. 174
-178.
M. Limoncelli, G. Donvito, Architettura longobarda in Puglia. Il Tempietto di Seppannibale presso Fasano (BR) , dall'analisi delle strutture alla restituzione 3D, in V Congresso Nazionale di Archeologia Medievale, Palazzo della Dogana, Salone del Tribunale ( Foggia ), Palazzo dei Celestini , Auditorium ( Manfredonia ), All'Insegna del Giglio, pp. 746 – 750.
M. Limoncelli, Seppannibale, Il Restauro digitale dei cicli pittorici, in Masseria Seppannibale Grande in agro di Fasano (BR). Indagini in un sito rurale (aa. 2003-2006), G. Bertelli , G. Lepore ( a cura di) , M. Adda Editore, 2011 , pp.116 -123.
M.L.
Semeraro Herrmann, L'Enigma
del tempietto di San Pietro Veterano di Fasano (denominato
Seppannibale),
Schena Editore, Fasano 2017.
R. G. Lombardi, Produzione e diffusione delle lucerne africane
tardoantiche nell’insediamento rurale di Seppannibale (Fasano-BR)
in LychnoLogicaL acts 3 , Actes du 3e congrès international
d’études sur le luminaire antique, Université d'heidelberg
(21-26. iX. 2009), Éditions
Monique Mergoil Montagnac, 2012.














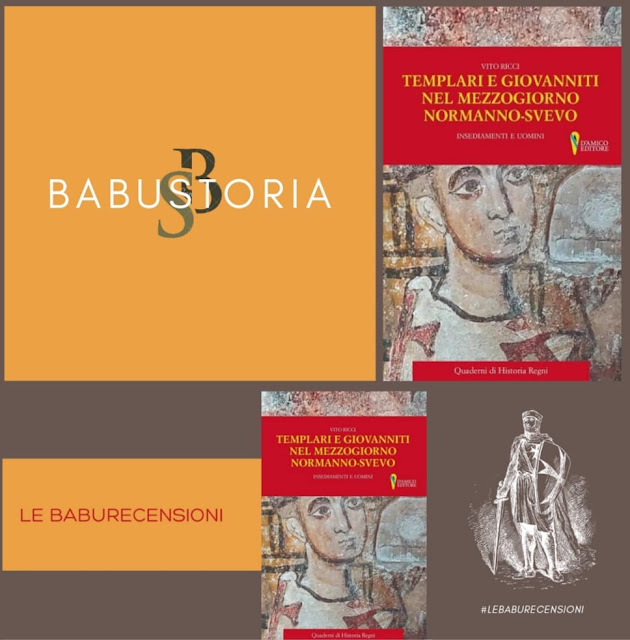

Commenti
Posta un commento