Ego sum homo tuus : il Feudalesimo in pillole
 |
| I fratelli giurano fedeltà al fratello e sovrano Childeberto, miniatura da Les Grandes Chroniques de France, 1275, Parigi, Bibliothèque SAinte - Genevieve, ms 782, f.16v. |
Anche nella società romana nessuno vietava ad un politico di avere la sua solida cerchia di sostenitori : potevano essere senatori o clientes ( povera gente che elemosinava denaro o da mangiare al suo patrono ). Sia i potenti romani della tarda antichità che germani ricompensavano questi fedelissimi in un qualche modo, con uno scambio di favori . E poiché l'economia era poco monetarizzata, se d'élite, i protetti erano ricompensati con parte delle terre del loro signore al quale giuravano fedeltà e aiuto . Questa gente si metteva nella mani di un personaggio più potente.
Le locuzioni "mettersi nelle mani di..." e "sono nelle tue mani", entrambe intese nel senso di affidarsi a qualcuno , derivano proprio dall' homagium feudale, la pratica rituale che legava il vassallo al suo signore.
Ovviamente il termine "feudalesimo" non esisteva nel Medioevo. Sono stati gli storici a chiamarlo in questo modo facendo riferimento al sistema vassallatico beneficiario costituitosi in alcune zone d'Europa tra IX e X secolo e poi, in modo più massiccio , tra XI e XII secolo.
La diffusione di questo fenomeno, che ben trova espressione nel periodo carolingio, non fu omogenea: se in Germania l'organizzazione feudale penetrò più tardi, nell'Inghilterra prenormanna i vincoli feudali non esaurirono per nulla la coincidenza tra fedeltà e concessione della terra. A questo proposito è emblematico il caso dell'Aquitania del Sud in cui alle istituzioni feudali si affiancò il concetto di libera proprietà e autonomia giuridica dei contraenti. Per feudo in Normandia e Bretagna si indicò ogni terra concessa da un signore a un contadino . Nel Lazio pontificio, il rapporto feudale comparve intorno al Mille con l'aquitano Silvestro II. Il modello franco, invece , si riscontra specialmente in Catalogna e Aragona.
Tutti gli uomini del re:
Parliamo di un mondo gerarchico , fatto di scambi e di favori . Il vassallo ( dal germanico "gwas", "uomo") era colui che giurava fedeltà al suo signore. Nei suoi confronti, faceva un atto di homagium, diventava cioè uomo di un altro uomo . In cambio di protezione, di armi, di cavalli , vestiti, rendita di denaro ( come accadeva in Lotaringia alla fine del X secolo) e soprattutto terre ( o feudi, dal tedesco "feohu", "oggetto prezioso" ) il vassallo doveva servire il suo signore militarmente, aiutarlo nell'amministrazione della giustizia, pagarne il riscatto se prigioniero, sostenerlo finanziariamente in caso di guerra , di viaggi a Roma o di lavori di ampliamento di edifici sacri.
Il rapporto stabilito tra signore e vassallo era sancito da una cerimonia ben precisa, l' Investitura.
Piena di riferimenti simbolici, prevedeva il giuramento del vassallo : costui con le mani giunte nelle mani del suo signore, gli prometteva fedeltà in cambio di protezione. Il giuramento veniva concluso con lo scambio del bacio reciproco. La fedeltà giurata era qualcosa che coinvolgeva entrambi i contraenti. Come infatti sosteneva Guglielmo d'Aquitania, non solo il vassallo, ma anche il signore doveva rispettare i patti per non essere considerato indegno del giuramento.
Il rapporto stabilito tra signore e vassallo era sancito da una cerimonia ben precisa, l' Investitura.
Piena di riferimenti simbolici, prevedeva il giuramento del vassallo : costui con le mani giunte nelle mani del suo signore, gli prometteva fedeltà in cambio di protezione. Il giuramento veniva concluso con lo scambio del bacio reciproco. La fedeltà giurata era qualcosa che coinvolgeva entrambi i contraenti. Come infatti sosteneva Guglielmo d'Aquitania, non solo il vassallo, ma anche il signore doveva rispettare i patti per non essere considerato indegno del giuramento.
Dall'alto del suo castello, centro del potere, il signore esercitava il dominio e il controllo sulle terre di sua proprietà. Di regola, era sempre il re ad averne possesso , delegando per sua volontà ad uomini di fiducia la gestione di altre proprietà a suo nome. Ma vi erano anche castelli costruiti contro la volontà dei re oppure strutture gestite autonomamente da ricchi prelati ( ricordiamo brevemente che anche la consacrazione sacerdotale prevedeva il rito dell' immixtio manuum molto simile all'omaggio feudale). Un tipo particolare di omaggio, in uso in Francia e in Lotaringia , era l' obbligatorio ligio : il vassallo poteva giurare fedeltà a più più signori, dichiarando in un secondo momento a chi , tra i vari, spettasse la precedenza in materia di obblighi feudali. Ben presto, si scoprì che molti vassalli prestavano questo tipo di fedeltà contemporaneamente all'omaggio classico. Il feudo (che in teoria il signore poteva riprendersi in caso di morte o tradimento del vassallo) a causa di fenomeni come questo e specialmente dopo la disgregazione dell'Impero carolingio, divenne ereditario, attestando la voglia dei vassalli di rendersi autonomi rispetto ai loro signori.
E così i feudatari maggiori iniziarono a rimarcare il loro potere , incrementandolo: la giustizia del re divenne giustizia comitale perché amministrata dai conti, suoi vassalli. Costoro organizzavano l'esercito per conto personale e non per ordine del loro sovrano. Inoltre , ancora vivente Carlo Magno, i conti potevano esonerare dalle prestazioni militari dovute al re quegli uomini liberi che avessero fatto loro dono della propria terra in cambio di protezione, usurpando di fatto un diritto pubblico! Questi conti mescolavano l' honor ( la concessione di un diritto all'esercizio della funzione pubblica) con il dominatus ( l'esercizio di un potere di fatto su uomini e beni.)
Nacquero diverse forme di potere locale:
- signorie ereditarie;
- signorie nate dalla concessione di terre in seguito a servizio armato prestato al re;
- signorie rurali formatesi dal basso, cioè dalla necessità delle popolazioni di difendersi da eventuali pericoli.
Con la dissoluzione dell'Impero carolingio, tra X e XI secolo , facendo leva su beni fondiari, fedeltà vassallatiche e vincoli di parentela, alcuni conti riuscirono ad imporre il loro dominio su ampi distretti , riconoscendo al re solo un omaggio formale. I conti di Fiandra o i duchi di Borgogna, Aquitania e Normandia ottennero potere in questo modo.
Per i castelli leggi anche:
"Le campagne nell'alto medioevo" clicca qui
"Le campagne nel basso medioevo" clicca qui
Bibliografia ed immagini:
C. Frugoni, La voce delle immagini. Pillole iconografiche dal medioevo. Einaudi, 2010
G. Piccinni, I mille anni del Medioevo, Mondadori , 1999
L. Cracco Ruggini, Storia antica. Come leggere le fonti, Il Mulino, 2000
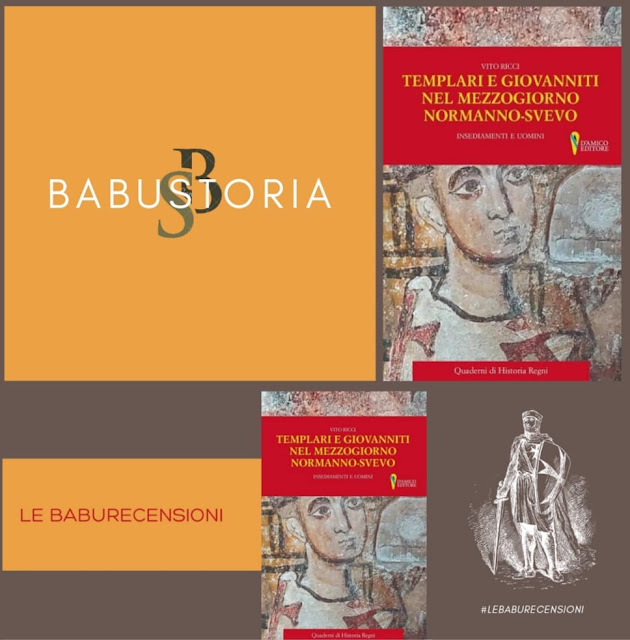

Commenti
Posta un commento