La simbologia cristiana: gli animali legati alla Passione di Cristo
Ho già parlato in pillole dei bestiari, quegli “strani libri di animali” (come direbbe M. Pastoureau), incentrati non tanto sulla zoologia o la storia naturale ma sul simbolismo e sul significato morale e religioso delle creature. Trattavano di animali non solo reali ma anche fantastici. Tramite la loro descrizione, i bestiari glorificavano il Creatore e la Creazione, narrando dei vizi e delle virtù degli uomini in chiave allegorica poiché legati ad un essere fantastico o animale in particolare. La loro rappresentazione poco realistica non deve stupirci. Chiunque studi storia dell’arte o si confronta con questa materia, troverà più attinenza al reale da parte degli artisti di fine Medioevo rispetto a quelli precedenti. Questo non perché gli artisti altomedievali fossero meno bravi o capaci rispetto a quelli basso medievali ma semplicemente perché nei bestiari la rappresentazione non era fisica e reale ma convenzionale e allegorica. Infatti , riprendendo le parole di M. Pastoureau, per la cultura medievale preciso non significa vero. Ribadiamo che gli uomini e le donne del Medioevo sapevano benissimo osservare il mondo attorno a loro solo che nella rappresentazione delle sue componenti vegetali o animali il vero e il simbolico avevano maggior importanza. Infatti, per realizzare la fauna desiderata, il compilatore del bestiario si basava su credenze e sull’aspetto della creatura considerata, procedendo per paragoni, metafore, etimologie o similitudini per dedicarsi infine alle conclusioni morali e religiose. Ricordiamo inoltre che, coprendo ben mille anni, il Medioevo non ha considerato in modo omogeneo uno stesso animale: al di là delle scarse conoscenze zoologiche del tempo, ad esempio la considerazione del cane o del gatto cambiò dall’epoca carolingia a quella di Giovanna d’Arco. In generale, i bestiari rivestirono considerevole importanza a partire dal XII secolo e per tutto il XIII secolo nella predicazione, nella scultura romanica , nei racconti e nelle favole ma anche nei proverbi , nei sigilli e negli stemmi.
 |
| Tre caratteristiche del Leone (1240 circa): a) é nemico della scimmia; b) é venerato come un dio in Etiopia ; c) il gallo bianco é l’unico animale che gli incute paura |
Abbiamo detto che gli animali dei bestiari erano in realtà allegorie o simboli che alludevano al Creato, ai vizi oppure alle virtù degli uomini. Di notevole importanza sono quelli relativi alla Passione di Cristo.
 |
| Il pellicano, particolare da una Croce da altare, inizio XIV secolo , Santa Vittoria in Materano , Chiesa di Santa Vittoria |
In generale il Medioevo é affascinato dai volatili : nei bestiari ad essi sono legati simbolismi e poteri particolari, anche magici. Nei bestiari latini i capitoli ad essi dedicati sono così corposi da formare spesso delle opere a parte. Si parla di aviari : il più celebre fu il De avibus di Ugo di Fouilly , canonico regolare in Piccardia ( regione settentrionale della Francia, capoluogo Amiens). Sulle rive del Nilo i bestiari segnalano la presenza del pellicano , una creatura bianca, pulita e virtuosa. Dall’antenato del bestiario , il Physiologus ( “ Il naturalista”, testo vergato ad Alessandria d’Egitto in greco verso la fine del II sec. d. C), fino agli scritti medievali definiti con questo nome, il pellicano ha un comportamento degno di ammirazione. Egli infatti si ferisce per rianimare con il suo sangue i piccoli nati morti. Questa é per eccellenza l’immagine di Cristo che ha versato il suo in remissione dei nostri peccati. Parecchi testi arricchiscono la vicenda di particolari interessanti: i piccoli affamati beccano entrambi i genitori. Ma se il padre pellicano li becca a sua volta infastidito per volarsene via, la madre invece, in preda al dolore, si ferisce il fianco per nutrire i suoi piccoli. Altre versioni raccontano l’opposto inquadrando nel pellicano maschio il Dio Creatore che toglie e dona la vita. Alla fine del Medioevo il pellicano divenne l’emblema della carità . L’unica eccezione la troviamo nel Bestiaire d’Amours in cui Richard de Fornival descrive il pellicano come un animale carnale e mondano, egoista come la dama che non ha contraccambiato il suo amore. Tranne questa fonte il pellicano rappresenta i Dio padre che sacrifica il figlio o Cristo che si immola per i nostri peccati. Persino Dante usa questa immagine per definirlo. Egli é “il nostro pellicano” (Paradiso, XXV, vv. 112 - 114).
 |
| La resurrezione dei lenocini ( 1200 -1210 circa) |
Tra i quadrupedi, il posto d’onore spetta al leone . Abbiamo già trattato questo animale in relazione alla detronizzazione dell’ orso. Infatti al declino di quest’ultimo troppo legato al paganesimo, corrisponde nel XII secolo l’ascesa del leone. Su questo animale, conosciuto sin dai tempi dei romani, sia i bestiari latini che quelli in volgare si dilungano notevolmente , presentandolo come il re degli animali o delle bestie selvatiche. Signori e abati spesso ne avevano di vivi, esibendoli come emblemi viventi di grandezza e potere.
Bisogna comunque ricardare che nella Bibbia , sia nell’Antico che nel Nuovo Testamento, il leone viene descritto come crudele, terribile e temibile: insomma una creatura quasi infernale. Questa idea é condivisa da una parte dei Padri della Chiesa, primo tra tutti sant’Agostino. Una altra parte di loro ( sant’Ambrogio, Origene, Rabano Mauro) e in generale la Chiesa cristiana accettano un altro tipo di leone , emblema delle più auliche virtù: un animale coraggioso , il cui ruggito é espressione della parola di Dio. Le virtù leggendarie del leone, di origine orientale, sono di natura cristologica:
- il leone se inseguito dai nemici cancella con la coda le sue orme così come Cristo nasconde la sua divinitá incarnandosi in Maria per ingannare il diavolo;
- il leone se risparmia una preda é Dio misericordioso verso un peccatore pentito;
- il leone se dorme ad occhi aperti é il Cristo nella tomba ;
- il leone se arrabbiato pesta le zampe per terra così come Dio protegge i buoni e castiga i cattivi;
- il leone se va a caccia e segna un cerchio con la coda da cui gli animali non vogliono più uscire è Dio che delimita il Paradiso con all'interno i meritevoli;
Una proprietà molto interessante del leone é quella di riportare in vita i leoncini morti il terzo giorno tramite il suo respiro. E' il cronista Giovanni Villani ad annotare questo prodigio intorno al 1331. L'immagine del leone che resuscita i suoi piccoli è molto singolare ed è stata variamente ripresa anche nella più moderna letteratura. Il caso più noto é quello di Aslan nelle Cronache di Narnia di C.S. Lewis : Aslan é una creatura dal ruggito poderoso, capace di riportare in vita gli esseri trasformati in pietra dalla strega cattiva con il suo fiato , coraggioso, dotato di forza eccezionale, chiamato, come egli stesso dice ai fratellini protagonisti del racconto, in modo diverso sulla Terra. In Aslan si rivede la perfetta incarnazione di Cristo ( ovviamente giusta , benigna e misericordiosa) .
Ma attenzione!
Anche il leone ha le sue debolezze: in primo luogo la caccia (anche se è sempre pronto a dividere il suo pasto come un bravo signore con i suoi vassalli). Riccardo I d'Inghilterra è passato alla storia con il soprannome di Cuor di Leone proprio per il coraggio dimostrato in battaglia nel combattere sempre in prima linea.
I bestiari medievali segnalano un altro malus per il leone: la paura verso i galli bianchi. Non c'è una spiegazione univoca a proposito. Si pensa che questa credenza sia stata tratta dal rinnegamento di Pietro (associato al leone) al canto del gallo .
Nonostante queste debolezze , il leone rimase l'animale più raffigurato su stemmi e blasoni medievali. Questo primato rispetto ad altri animali (come l'aquila), è attestato ovunque tra XII e XIV secolo . Alla base di tale successo, si evidenzia anche la massiccia influenza orientale durante il periodo delle crociate (in virtù della circolazione di tessuti , avori e preziosi). Ad eccezione della Francia e del Sacro Romano Impero, tutti i sovrani europei hanno avuto sui loro stemmi o blasoni l'effige del leone con significative differenze ( abbondava di più nelle Fiandre e nei Paesi Bassi rispetto alla Svizzera, all'Austria e , in generale, alle zone di montagna). Tutti attestano la sua importanza e sovranità come re degli animali e della foresta : egli è di frequente raffigurato di profilo, in posizione rampante , cioè in verticale ritto su una delle zampe posteriori. La sua scomparsa figurativa in campo araldico si attesta tra XIII e XVII secolo a causa della diversificazione dei soggetti ritratti.
 |
| La resurrezione degli orsetti , 1200 - 1210 circa |
Bibliografia e immagini:
C. Frugoni , La voce delle immagini. Pillole iconografiche dal Medioevo, Einaudi, 2010
M. Pastoureau, L'arte araldica nel Medioevo, Einaudi, 2019

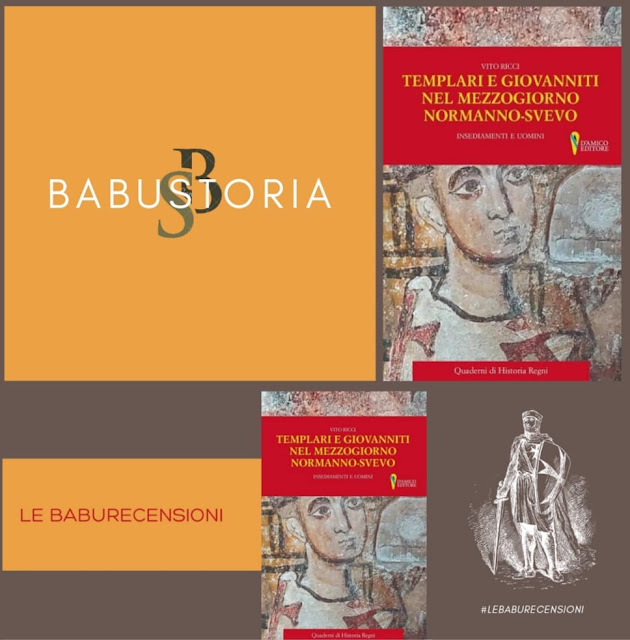

Commenti
Posta un commento