La vita del soldato
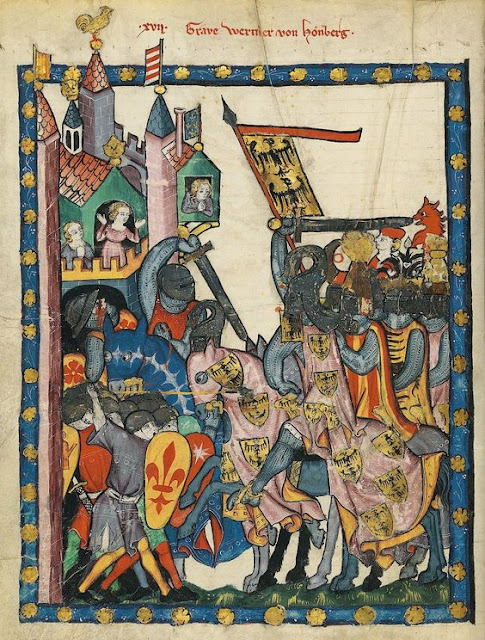 |
| Miniatura tratta dal Codex Manesse, 43v |
 |
| Manoscritto Bodley 352, folio 6v, Bodleian Library, Germania, 1100 -1150. |
Sì, l'estate era tragica. Esempio importante è quello riportatoci da Giovanni Villani. Cascina, 1364. Il conflitto tra Firenze e Pisa esplose in quell'assolato luglio e Giovanni Acuto, condottiero britannico al soldo dei pisani, "aspettò la volta del sole perché li raggi fedissono nel volto delli nimici e a' suoi nelle spalle". Inoltre , prima dello scontro vero e proprio, per ingannare Galeotto Malatesta, il comandante fece in modo di far levare "meno polverio" facendo avanzare i suoi a piedi (per quattro miglia!) anziché a cavallo. Ricordiamo questa battaglia anche per un altro motivo: la perdita del famoso "cartone" michelangiolesco raffigurante Cascina non come un accampamento ma come un campo estivo in cui i fiorentini, colti dalla calura e dalla voglia di freschezza, disarmatisi, si gettarono nell'Arno nel mentre il Malatesta, ormai sessantenne, "se n'era ito nel letto a riposare". Ovviamente, con queste premesse, alla fine vinsero i pisani.
Non è raro trovare una cappa di polvere nel cielo di tutte le battaglie tra XII e XIII secolo: il 70% delle operazioni militari era infatti concentrato fra maggio e agosto. Spesso , la polvere era così fitta da ostruire la vista ( Nicosia, 23 giugno 1229). La polvere, si univa al problema acqua: Antonio Campano racconta dello scaltro Braccio da Montone il quale, alle porte di Perugia nel 1416, riuscì ad assicurare ai suoi degno approvvigionamento idrico in barba ai nemici, fustigati da sole, polvere negli occhi e stanchezza. La stanchezza fisica era un altro gravoso problema in combattimento. L'Anonimo Cumano scrive a proposito della battaglia di Rebbio : "Il sudor cola, scorre a rivi per le matide membra. Sangue stillano ovunque i polverosi campi. ". I combattenti, stanchi, sedevano per terra , cercando il ristoro dell'acqua. Per questo motivo, Vegezio prima e Egidio Romano (De regime) poi, suggerivano di abituare sin da fanciulli i futuri soldati alla fatica. Il concetto viene ripreso anche negli Insegnamenti di Teodoro di Monferrato . Sole, polvere, mancanza d'acqua, stanchezza e... armature. Nel corso del tempo divennero più complesse e pesanti. Forse sin dall'età carolingia si iniziò ad insistere sul senso di invulnerabilità dei guerrieri attraverso di esse. Nel Medioevo , in generale, le armature si aggiravano intorno ai 25 kg. Nel corso del XIII secolo , si introdussero elementi in lamiera , più difficili da perforare dalle balestre ma scomodissime perché non traspiranti. Inoltre , armature così composte , potevano provocare dolori alla schiena e alle articolazioni.
 |
| Guerrieri a riposo, Morgan, M.106, Salterio, f031v, 1255-1265, Belgio |
Ma, attenzione all'organizzazione! Vi era un vettovagliamento a monte: si partiva sempre con delle scorte esplicitamente richieste al momento dell'arruolamento. Ad esempio, Carlo Magno esigeva dai suoi soldati in adunata viveri per tre mesi. Inoltre ogni mobilitazione era accompagnata da derrate alimentari tra cui farina e vino. Tra XII e XIII secolo non sono rare le notizie di carri pieni di "cibi e armi" al seguito degli eserciti. Spesso, durante la discesa di una schiera armata, si prendevano accordi con le città alleate per il vettovagliamento. Ma non sempre andava tutto bene. Federico II, diretto nel 1154 dalla piana di Roncaglia verso occidente, avrebbe dovuto ricevere rifornimenti dai milanesi a Landriano ma, non avendo ottenuto sostentamento sufficiente per uomini e cavalli, rimandò indietro nudi i negozianti che gli avevano portato le vettovaglie.
 |
| Miniatura tratta dalla Bibbia Maciejowski, XIII secolo |
Nell'Europa altomedievale, carne e pane erano i cibi primari. In verità, studiando le provviste dei crociati lombardi e tedeschi in Terrasanta troviamo anche frumento, vino e altri beni come carne, orzo (per i cavalli) , olio, formaggi, frutti, polli, uova e noci. "Colui che ha viveri combatte con più sicurezza di chi non ne ha", diceva a ragione Enrico Dandolo, doge di Venezia. Egidio Romano, a proposito della conduzione di un assedio, raccomandava di fornirsi di frumento, avena , orzo, miglio ( si conserva meglio e più a lungo), sale, carni salate ( ricavate dalle bestie non indispensabili), acqua fruibile da pozzi, cisterne, aceto e vino. Quando i viveri scarseggiano era naturale cadere nell'incertezza e...il pretesto per derubare villaggi si faceva più insistente. Le razzie dei soldati, provocavano delle "carestie artificiali" di cui erano causa e vittime. Se il cibo scarseggiava , spesso si doveva ripiegare su quanto era rimasto in deposito, come le fave novelle di cui si cibarono i crociati sulla strada di Gerusalemme nel 1099 , oppure piante spinose alla stregua dei soldati in Asia minore nel 1097. Sempre nel 1099 , si raggiunse il colmo: a Marra, dopo aver sezionato e tagliato i cadaveri dei Turchi, taluni soldati commisero cannibalismo.
.jpg) |
| L'accampamento, dettaglio del ciclo affrescato del castello di Teruel |
Ma com'era organizzata la questione del cibo? Ai militari toccavano delle razioni? E' possibile farsene una idea studiando gli ultimi due secoli del Medioevo. Le fonti parlano di pane (o biscotto) , carne (ovina, bovina o suina) , pappe di piselli e fave, condimenti a base di lardo e burro. In caso di astinenza imposta d'ufficio, alla carne subentravano pesce affumicato o salato, uova e formaggi. Si utilizzavano sale, aceto, aglio e cipolla. Le spezie erano riservate alla cura dei malati. Il vino, bevuto dai capi e dai cavalieri. spettava alle truppe solo nei giorni festivi e di combattimento. In Francia, era sostituito dalla birra o dal sidro. La vita del guerriero era sempre sul filo del rasoio: bisognava star attenti anche ad organizzare i pasti. Spesso e volentieri, infatti, il nemico sopraggiungeva nei momenti di stasi, come appunto quello del desco.
 |
| Lanciatore di pietre, MS M. 638, Morgan Crusader Bible, St. Louis Bible Date , Parigi Francia, ca. 1244-1254, folio 28v |
 |
| Ferite di guerra, miniatura dal Willehalm, inizio XIII secolo. |
Bibliografia:
A. Albuzzi, Medicina , cibus et potus. Il vino tra teoria e prassi medica nell’Occidente medievale in "La civiltà del vino. Fonti, temi e produzioni vitivinicole dal medioevo al Novecento. "Atti del Convegno (Monticelli Brusati - Antica Fratta, 5-6 ottobre 2001), a cura di Gabriele Archetti , con la collaborazione di Angelo Baronio, Roberto Bellini, Pierluigi Villa, Brescia, Centro culturale artistico di Franciacorta e del Sebino, 2003 (Atti delle Biennali di Franciacorta, 7), pp. 675-712.
A. Giallongo, Il bambino medievale. Storie di Infanzie, Cap. V, Dedalo, 2019A. Settia, Battaglie medievali, il Mulino, 2020
A. Settia, Rapine, battaglie, assedi. La guerra nel medioevo, Laterza, 2009
Articoli correlati:
Il mestiere del cavaliere
Il codice cavalleresco
Il torneo nel Medioevo
Attacco e difesa
Un cavaliere del Duecento
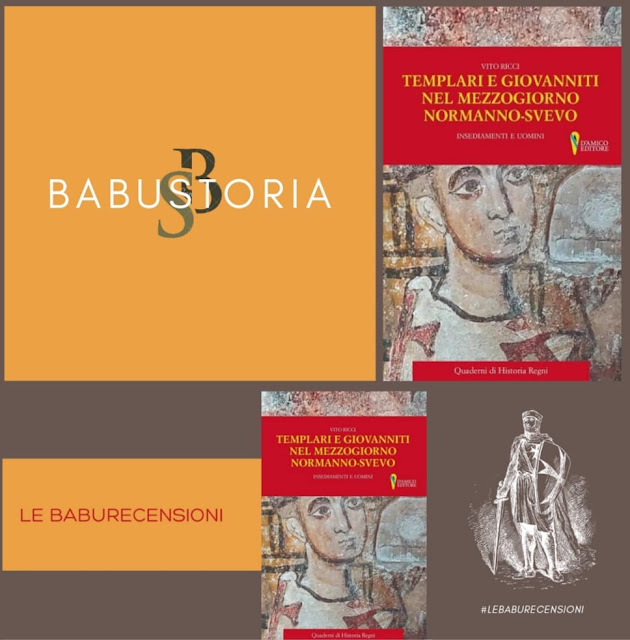

Commenti
Posta un commento